
La Volkswagen a noleggio ha i sedili riscaldati.
Chi di noi due non è al volante, deve leggere ad alta voce un capitolo di Anime baltiche, di Jan Brokken. Scopo, immergersi in apnea nella cultura locale.
A -15° la lingua fatica a sciogliersi.
Fortuna che il nostro suv con pneumatici da neve ha i sedili riscaldati.
Guidiamo fuori Vilnius, ex Gerusalemme del Nord sino alla falce uncinata che ne amputò l’arto ebraico. Poche vestigia rimaste.
È il gemello siamese della Polonia. La terra dello scrittore Romain Gary e del violinista Heifetz. Un paese il cui primo presidente fu un pianista, un paese che ha fatto la rivoluzione cantando e da cui provenivano i nonni di Bob Dylan.
Tappe a Kaunas, l’ex capitale. Al buio scenario lacustre del castello di Trakai. Al verde Veronese delle campagne di Rumšiškės, dove le baite vuote del museo a cielo aperto fanno effetto videogioco.
Si guadagna la costa al quarto giorno, raggiungendo la città portuale di Klaipeda che guarda di fronte a sé una strana penisola. Inconsueta assenza di un ponte per uno stretto di mare tanto breve. Bisogna imbarcare l’auto su un traghetto che in un quarto d’ora porta dall’altra parte. Sull’istmo di Neringa.
Neringa è una lingua di terra che tira dritto, sottile come una cerniera, fino all’Oblast russa di Kaliningrad, separando il Mar Baltico dalla Laguna dei Curi. Oltre l’Oblast ne spunta un’altra, che disegna la Laguna della Vistola fino a Danzica. Ex Pomerania.
Si va cauti, i russi vigilano che non si sfrutti quell’esile zerbino per entrare in casa loro. Casa, poi. L’exclave di Kaliningrad è più una dépendance. All’inizio dell’unica strada che sfila dentro le fitte conifere costrette su quello scoglio bislungo, si travisa il passaggio a livello che impone di pagare una sorta di dazio. La guardia ci scruta facendo il gesto di una telecamera e minacciando: “Policja!”
Momento di gelo. Fortuna che la Volkswagen ha i sedili riscaldati.

Dopo il solito stralunato tramonto alle 15:30, si va in caccia di ortaggi. Due vegetariani in Lituania sono come due vecchi sdentati in un campo di pannocchie.
Il promettente “Frau Kirsche” è in realtà la hall di un centro commerciale chiuso, atro e stantio. Sul punto di restarci ugualmente, per pura pigrizia, ci riscattiamo a colpi di reni e affrontiamo la temperatura serale fino a un pub, con due birre, una zuppa di funghi e una spadellata mista di non-carne.
I divanetti sono troppo bassi e distanti dal tavolo per riuscire a star seduti in modo dignitoso. Questo impedisce di scendere in discorsi più intimi. Poi c’è troppa luce. Troppe famiglie che producono suoni standard su timbri diversi, fra lamenti-bambini e rimbrotti-genitori, come un rotismo che cigola.
Veniamo infine presi all’amo da un quarantenne brillo, vestito da cresima, che ci tiene un mondo a verbalizzarci. A strapparci di dosso l’aura da stranieri a colpi d’inglese flesso e orientale. Dalla briciola di uno spunto, sbava domande come un ragno. Chiede di sedersi con noi. Ci offre da bere.
Ha gli occhi vacui, forse gli son cascati nel bicchiere. I capelli pettinati da un lato, come a nascondere il rossore innaturale dell’alcol sulla sua pelle bianco merluzzo.
Dice di chiamarsi Mindaugas, è un ricco imprenditore. Il vestiario adesso si spiega.
Sul libro di Brokken abbiamo letto che Mindaugas è stato il primo Granduca di Lituania, nel XIII secolo. Il grande riunificatore del paese. Chissà se ci ha mentito.
L’uomo tenta varie strade per accattivarsi qualcosa della nostra attenzione, anche solo un lembo, una reliquia. Ci offre degli shot, vuol pagare il conto della nostra cena. Estrae perfino di tasca le chiavi di una sua presunta villa offrendocela per la vacanza.
Sull’altro piatto della bilancia dev’esserci qualcosa che gli manca terribilmente. Qualcosa che a noi invece sembra così leggero, una forma di semplicità.
Rifiutiamo senza troppa convinzione e una punta d’inquietudine curiosa. A letto quella sera, non riesco a dormire.

La sindrome da scrittore proietta avanti sullo schermo della fronte ciò che sarebbe-stato-se avessimo accettato le maledette chiavi di quell’incognita villa.
Paul Valéry parlava di implesso, immaginando nuclei di realtà contenenti le loro verità inespresse. Definiamoli grappoli di avvenimenti potenziali, dai quali la Storia spicca singoli acini avverandoli. È la funzione d’onda di Schrödinger.
La sensazione volpina di aver mancato l’uva mi mordeva. Che il sentiero biforcuto imboccato tornando a casa fosse un cul-de-sac, con Borges a ghignarsela a destra e Robert Frost a sinistra. Stuck in the middle.
Certo, avendo infilato nello zaino la Trilogia della città di K., forse sono solo suggestionato dai cumuli di destini paralleli plasmati dalla Kristof sottoforma di menzogne. Forse sto solo cercando di vendicarmi di una notte insonne. Ma la fame onirica di un senso inesistente traccia una grana grossa nel buio e separa due emisferi come un quadro di Rothko.
Uno. Se fossi stato un Hemingway, rimpiangevo, avrei preso quelle chiavi, sarei corso incontro all’occasione. Sarei stato il fautore del mio stesso racconto, vivendolo in prima persona. Non puoi narrare niente che non hai vissuto sulla tua pelle, imponeva Ernest accusando il suo amico e scrittore canadese Morley Callaghan per aver scritto sulla boxe senza aver mai tirato su un ring. I due si sfidarono. Fitzgerald fece da arbitro. Hemingway andò al tappeto.
Due. Se invece fossi un Proust, proseguivo malinconico, sarei fuggito nella direzione opposta al fuoco dell’evento. Sarei andato a letto presto, mi sarei fatto eseguire un concerto da camera da César Franck sdraiato fra le lenzuola e infine, al sicuro nella mia cameretta, avrei leopardianamente sfogato la mia inettitudine alla vita sviluppandola altrimenti sulla carta.
Il sangue è il mio inchiostro! (Hemingway). L’inchiostro è il mio sangue! (Proust).
Seguendo questi due Virgilii, divento strabico portandomi ai loro estremi. Da una parte l’Iperrealismo, raccontare esattamente quanto successo facendolo succedere (la nascita di Tristram Shandy, la giornata di Leopold Bloom, il condominio di Georges Perec). Dall’altra la Metanarrazione, l’autore che diventa protagonista e racconta di sé stesso tentare invano il racconto (la seconda parte del Chisciotte, gli sperimentalismi di Landolfi, Pirandello, Calvino etc.)
In mezzo si assottiglia una lingua di terra, simile alla penisola di Neringa, folta della conifera del linguaggio, incorniciata dagli scogli della grammatica e della sintassi, duri massi a volte smossi da onde più potenti di loro che portano novità. A largo, le alture di due oceani abissali: la tautologia, cui scivola l’Iperrealismo quando va alla deriva nel didascalico, e la contraddizione, cui danno adito i paradossi della Metanarrazione.
Come diceva Wittgenstein, il linguaggio agisce nella stretta feritoia fra questi due blocchi, il truismo e l’aporia. La letteratura di pari passo.
La domanda per conciliare il sonno allora è: che vento seguire per un eventuale racconto?

I dettagli! I dettagli, naturalmente. Il punto croce dell’ispirazione.
Nel sonno tornano a galla come fiocchi di ricotta. Quando, ad esempio, Mindaugas ha fatto i complimenti ai miei occhi, ostensivamente snobbando i più avvenenti della mia compagna, l’alone di omosessualità, abbinato agli shot offerti in cui avrebbe potuto inoculare del sonnifero con effetto a scoppio ritardato, trasformano narratologicamente la villa nella sua sala di torture.
La giovane e ingenua coppia che si lascia trasdurre nella dimora di un abominevole traviato, che poi svengono per effetto di un narcotico e si rianimano in un salone dai contorni medievali, con falcioni e picchi d’armi a becco di corvo appesi alle pareti, da cui spuntano candelieri e musi di impagliati camosci.
Possono così cadere oggetto di sevizie, ma inattese (per non essere scontati), tipo qualcosa di pochade e farsesco come strofinargli una buccia di pesca sui denti o cerette al perineo. Arieggia Catullo.
Oppure qualcosa di sadico, come lo sfregio lento e graduale al viso di lui per mettere alla prova quanto l’amore della fanciulla prescinda la bellezza, o a quale cifra è disposta a prostituirsi di fronte al suo ragazzo (si scopre che esiste un prezzo per tutto). Ci vorrebbe Lautréamont.
Rubare da storie captate altrove è sleale abbastanza da addirsi a uno scrittore. Accarezzo l’idea di servirmi di un pettegolezzo circa una mia amica che pratica bdsm, la quale ha ricevuto la proposta da un vecchio sciatto, vestito in bretelle e calzoncini alla zuava, di vederla accoppiarsi con un uomo di fronte a lui e, su sua richiesta, alzarsi poi marciando sui tacchi per schiacciare col tallone un Duplo al cioccolato. Quando lei ha chiesto se si poteva usare un altro genere di snack, il prosseneta ha precisato scandendo a fondo le sillabe: “No, solo un Du-plo”… Apollinaire non avrebbe saputo far di meglio.
Dire ormai che non me la sono sentita d’interpolare questa digressione, non solo si chiama preterizione (figura retorica che edulcora il termine “ipocrisia”), ma rischia di farmi inciampare di nuovo nella Metanarrazione. Abbandono il filone.

Secondo dettaglio. Durante l’alticcia conversazione, il nostro milionario ha biasimato le bandiere gialloblu a supporto della guerra in Ucraina, erte ovunque di fianco a quella nazionale sulle facciate dei palazzi pubblici. Rifiutate poi le chiavi della villa, si è giustificato dicendo di non essere certo un oligarca, bollandosi così indelebilmente come tale nella mia fantasia.
Si può quindi scendere verso un intrigo di mafia russa, alla Cronenberg, alla Lilin. D’altronde, la malfamata Kaliningrad è a un tiro di balestra. Forse Mindaugas è invischiato in un traffico di organi umani o ha bisogno di due innocenti per una sostituzione di cadaveri a coprire un omicidio. Oppure, in cerca dell’arzigogolo, egli cerca qualche outsider per fare una consegna perigliosa, e così il contenuto del pacco apre il delta alle cose più eteroclite:
- Un dossier segreto che riconduce alla CIA l’attentato fallito a Dugin (thriller internazionale alla Graham Greene).
- Il cranio ripulito e laccato argento della Politkovskaja, trafugato e in viaggio verso Mosca, affinché Putin ci brindi in segreto con del Beluga riserva speciale (black humor alla Irvine Welsh, con inserti slavisti di Carrère).
- Lo specimen di un’opera incompiuta di Kant, nascosta nella biblioteca privata di E.T.A. Hoffmann prima che venisse cacciato da Königsberg (ex Kaliningrad), intercettato da Hannah Arendt e in grado di scatenare un putiferio editoriale per scabrosi contenuti (Umberto Eco a mani basse).
Altrimenti, per dare una rasoiata alla Ockham, basti il piano sequenza dei due ragazzi che, guardinghi ma attratti, seguono il lituano fino alla villa, finché questi viene freddato sulla soglia di casa da un regolamento di conti. I due si ritrovano soli, con le chiavi della villa in mano, presi dalla tentazione di approfittarne.
Quest’ultimo vettore richiama un altro dettaglio rimasto in secondo piano. Se il nostro riccone avesse davvero offerto la cena ai due fanciulli, non ci sarebbe stata sulla loro carta di credito, né in nessun altro elemento, alcuna tracciabilità di quell’incontro casuale. Con un ribaltone, si scoprirebbe che i due giovani sono in realtà complici di crimini occasionali, una coppia alla Natural Born Killers, alla Badlands. I fatti di sangue in cui si sbizzarriscono nella villa ai danni del povero magnate, prima di darsi alla macchia in pieno anonimato, si possono giocare a cavallo fra un reportage alla Capote e una danse macabre come nei Racconti neri di Scerbanenco.

L’insonnia si uncina poi a un ultimo dettaglio, quando Mindaugas, all’ennesimo bicchiere, si è scucito con noi sull’insensatezza della sua vita. Diceva di non amare sua moglie, che non comprende i suoi figli. Coi soldi può ottenere tutto, tranne ciò che vorrebbe davvero.
Sale la tentazione di un racconto a sfondo vagamente morale, meglio non troppo edificante (Dickens, Zola), ma più una pennellata impressionista alla Maupassant/Čechov, o magari formato fiaba alla Wilde, in cui il principe infelice fa dono del suo maniero ai due giovani, i quali scoprono essere appartenuto a un antico Granduca, raffigurato a tinte olio in un possente ritratto nel salone. I lineamenti del volto mostrano l’aspetto del nostro milionario. Un vecchio guardiano spiega loro che morì suicida secoli orsono per solitudine d’affetti. Mindaugas era un fantasma.
Per chi beve caffè amaro, si potrebbe altresì sospettare che la villa custodisca i corpi della sua famiglia di cui si è liberato in un eccesso di follia. Hodgson, pensaci tu.
Ovviamente, non importa l’esito all’interno di un simile spettro.
È fondamentale soltanto scandire un ritmo che consenta al lettore di adombrare più chance. Fargli sentire sotto le dita le gemme e i polloni sul tronco maestro, da cui potrebbero spuntare nuovi rami. Dargli il tempo di sondare le variabili, le decoerenze dei racconti invisibili che non vedranno la luce.
È il lettore il fautore dei destini mancati.
I romanzieri gialli sono luminari e abduttori di questa tattica. La somma dei loro indizi è anti-olistica, è sempre cioè superiore al dato cruciale che svela il mistero, perché si deve disorientare il lettore verso false piste. Ebbene, queste “false” piste, sono i “veri” strali di un racconto avvincente.
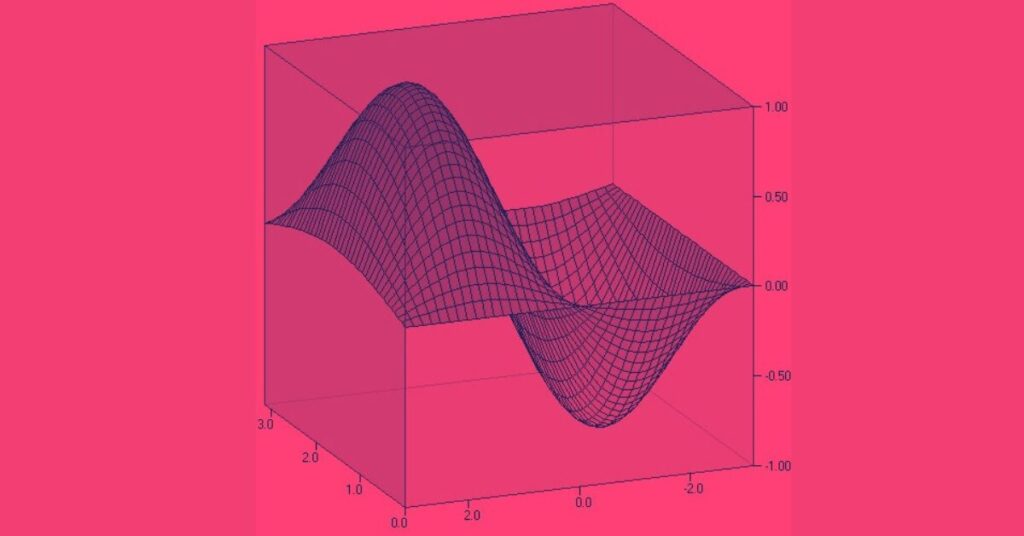
Io ho scelto per il mio epilogo un inno al pentimento.
Sdraiato a letto e in attesa di un’alba nordica e tardiva, col sobrio respiro dormiente di fianco a me di una donna che apprendo a desiderare, dove sta il nerbo di questa insoddisfazione letteraria se non nel rimorso di essermi lasciato sfuggire qualcosa?
Il rammarico fa da stecco per lo zucchero filato di una fantasia candita e diabetica, pronta a leggere sul giornale l’indomani la ghiotta storia di un giovane imprenditore lituano, ritrovato nottetempo privo di vita all’interno della sua villa sul Baltico.
Domani è capodanno. C’è bisogno di un plot twist per l’addio a quest’ennesima roulette russa di ore, giorni e stagioni. Domani darò alla mia ragazza orecchini di onice incastonati di zircone. Nero e bianco, i suoi colori. Le chiederò di andare a vivere insieme.
Al capolino dell’aurora, capisco che questo coacervo di sogni interrotti è il racconto stesso. Ma senza Metanarrazione. I personaggi non siamo noi, gli orecchini di onice e zircone si trasformano in un anello, l’orologio si sposta avanti di un giorno.
Quando Mindaugas si era seduto al tavolo coi due ragazzi, fingiamo che lui stesse per chiedere a lei di sposarlo, proprio la sera di Capodanno. Il ricco ubriacone li avrà interrotti, avrà mandato a monte il loro momento speciale. Il ragazzo dunque ha rinunciato. Ha rimesso le fedi in tasca. Il pentimento per non aver assecondato la follia di seguire uno sconosciuto fin dentro una villa alla Eyes Wide Shut, in conclusione, non sarebbe il pungolo di uno scrittore mancato, quanto lo scrupolo di un futuro marito verso la madre dei suoi figli.

Gli implessi, i sentieri che si biforcano e i destini incrociati che hanno popolato i suoi sogni nella prima notte dell’anno, dimostrano al giovane di non essere pronto per il matrimonio. Di avvertire ancora fame di avventure, di itinerari cimentosi, di quelle vite parallele fuse a cuneo nella freccia del tempo che, per innestarsi sul bersaglio dei desideri, possiede in cima una cocca piumata aperta a ventaglio per volare spedita in qualunque direzione.



