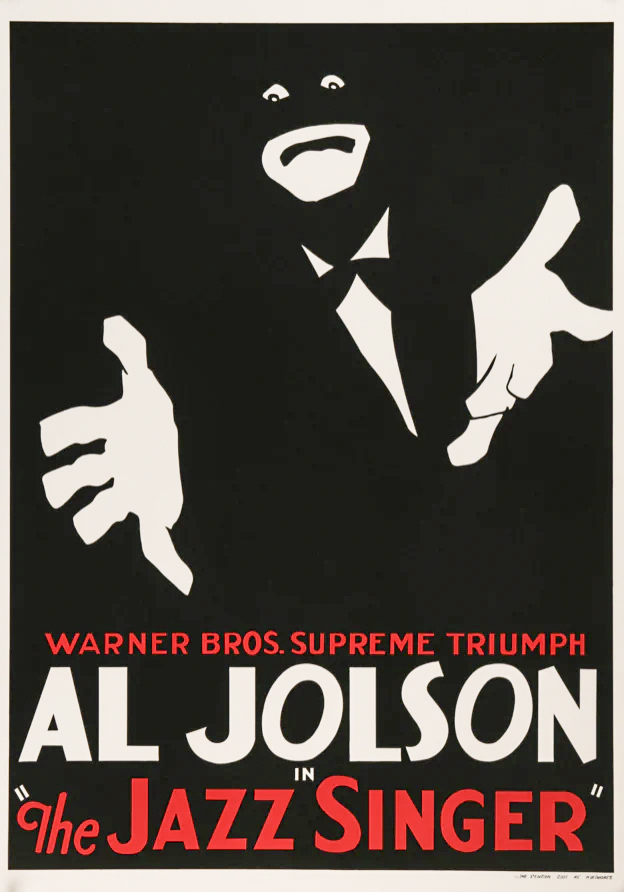di Giulio Bellotto
///
Dal marcio della Danimarca ai tentativi di emendazione dei secoli successivi che, all’interno della logica teatrale, chiedono alla rappresentazione di fornire una possibile soluzione al dubbio amletico. Ma tale dubbio, da sempre universale, è davvero valido per tutti?
«La recitazione [ha come fine] di reggere lo specchio alla natura, direi: di mostrare alla virtù il suo volto, al disdegno la sua immagine, e perfino la forma e l’impronta loro all’età e al corpo che il momento esige»[1]. Con queste parole Amleto raccomanda agli attori girovaghi giunti a Elsinor di recitare al meglio, quella sera, nella grande rappresentazione offerta al nuovo re per il diletto della corte, appena uscita da un grande lutto. Il padre di Amleto, il vecchio re, è morto e in Danimarca serpeggia una strana inquietudine densa di nebbia e di fantasmi.
«There is something rotten in the state of Denmark» è una delle più celebri battute teatrali di tutti i tempi[2], preceduta forse solo da qualche brano di Giulietta e Romeo e dal solenne: «To be, or not to be». Chiaramente le due citazioni, entrambe tratte dalla medesima tragedia, sono strettamente legate tra loro. Dalla metà del I atto all’inizio del III il pubblico viene infatti a conoscenza della reale situazione di decadenza in cui versa il regno; la medesima scoperta la fa Amleto. Potremmo dire che lo spettatore ha una focalizzazione interna rispetto all’eroe tragico. Il marciume danese, però, è fertile: ne emerge con forza una domanda, ovvia e naturale. Che fare? È questa l’essenza dell’«essere, o non essere», la cui parafrasi più immediata non riguarda affatto, come pure verrebbe naturale pensare, il suicidio (cioè la propria morte) ma l’azione da intraprendere riguardo la morte (o per meglio dire, l’omicidio) di qualcun’altro. Nella fattispecie il proprio padre.
Circa trecentoquarantanove anni dopo, in uno dei più riusciti drammi contemporanei sulla responsabilità morale[3], anche Arthur Miller affida a un suo personaggio una domanda molto simile a quella che Shakespeare accosta alle labbra di Amleto. Biff, il figlio del commesso viaggiatore Willy Loman, si chiede come affrontare un evento luttuoso che coinvolge la dimensione familiare, frequentemente portata in scena come specchio di una comunità nella sua interezza. In quest’ottica, dunque: agire o non agire, questo è il problema!
«Che fare?» è l’interrogativo con cui deve confrontarsi in ogni epoca un personaggio teatrale, motore primo dell’azione scenica. In Shakespeare, poeta di tempi più selvaggi, il dubbio amletico si risolve a favore dell’azione, della vendetta e della pazzia (vera o simulata che sia); al contrario la risposta data da molti dei caratteri creati da drammaturghi moderni è invece l’indifferenza e l’incapacità di reagire all’imputridimento.
Anche a teatro, insomma, «l’emendamento delle cose guaste ha sublime riuscita», come dice il saggio orientale. Purché si accetti il significato originario della parola, l’accezione di “ciò che è al limite”, sotto la soglia più alta: grandi eccessi, grandi passioni, grandi emozioni. Anche espressioni idiomatiche come “fare teatro” o “recitare il melodramma” confermano questo aspetto estetico ed etico del teatro. Che però, naturalmente, è anche molto di più.
Infatti Amleto, esortando gli attori a «reggere lo specchio alla natura», riprende la concezione classica del teatro, che secondo Cicerone è imitatio vitae, speculum consuetudinis, imago veritatis. Il teatro è dunque mimetico; ma è anche metodico, in quanto replicare ciò che è reale presuppone una sua conoscenza. Ecco che quindi quest’operazione non può produrre solamente una copia necessariamente manchevole del reale, ma genererà inevitabilmente consapevolezza; né sarà superflua, rispondendo anzi ad una delle più importanti necessità umane: il miglioramento di sé.
Non sorprende che anticamente il teatro fosse considerato sacro, associato alla manifestazione delle divinità e celebrato di conseguenza durante apposite feste. Non stupisce neppure che l’età romantica abbia attribuito alle rappresentazioni teatrali un valore quasi metafisico: da Oscar Wilde alla Scapigliatura italiana passando per la filosofia che vi ritrova l’Assoluto, i teatri nell’Ottocento erano luoghi estatici. Questa è la poetica del teatro: che attraverso l’arte drammatica – cioè il mestiere “paradossale” (come direbbe Diderot) dell’attore – l’interprete, che si è liberato del suo ego per recitare, mostra allo spettatore quella parte di realtà che come individuo non può affrontare. Teatro è una finzione che in scena si fa verità.
Pur essendo il frutto di una fantasia risalente a quattro secoli fa, l’esasperata, ambigua e dubbiosa umanità di Amleto è indubbiamente vera. Lo sancisce in maniera inappellabile la fortuna che la tragedia e il suo protagonista hanno goduto nel corso del tempo; non sarebbe possibile negare l’influenza che essi hanno avuto sulla forma mentis occidentale, che ne è al tempo stesso l’humus e il frutto. Il dramma stesso infatti è una pianta in fiore: dall’ingiustizia perpetrata dal fratricida Claudio germoglia in un nuovo ordine, che ovviamente prevede come azione rituale il sacrificio di tutti i personaggi coinvolti; a sua volta il dubbio gemma risolutezza e questo proprio grazie all’espediente meta-teatrale del III atto. Questa armonia stilizzata e studiatissima – perciò al contempo molto vera e molto finta, dunque pienamente teatrale – ricorda le forme aggraziate di un bonsai, in grado di rendere in una sola immagine le forme contorte del consesso umano; dunque Hamlet non è solo occidentale, ma diventa paradigma di tutta l’umanità. Ciascun uomo è Amleto.
Ma fino a che punto Amleto può essere ciascun uomo? In altri termini: posto che ci troviamo di fronte a un classico senza tempo o confini culturali, quanto è lecito interpolare il materiale originale per adattarlo alle esigenze dei singoli spettatori, per far sì che possano immedesimarsi nelle vicende scritte per un pubblico vecchio di secoli[4]? La studiosa di teatro antico Maddalena Giovannelli ha giustamente paragonato una buona riscrittura all’urna greca dell’Ode di Keats: «Con le sue figure sospese tra un passato perduto e un presente eterno, che danzano su note sempre uguali e allo stesso tempo diverse». D’altronde, il teatro mira a generare esattamente a quel tipo di movimento, eterno e infaticabile; la messa in scena, quale che sia, deve perciò essere primariamente una messa in vita, riportare il testo all’originario splendore togliendovi quando necessario la patina del tempo.
Questo fa ad esempio il Teatro Filodrammatici, le cui stagioni sono da anni all’insegna di “Tradizione (e) Tradimenti” drammaturgici, con una spiccata attenzione alla contemporaneità e agli autori viventi; questo fece Testori col suo Ambleto, capitolo della parodistica “Trilogia degli Scarrozzanti”, il cui finale è propiziato dalle promesse dell’amore proibito tra Ambleto e il Franzese.
Riveste un certo interesse il fatto che la regia di questo spettacolo, decisamente audace per i tempi, abbia portato la firma di Andrée Ruth Shammah, in gioventù artista d’avanguardia e ora imprenditrice di uno dei teatri multisala più grandi del panorama milanese. Il Franco Parenti infatti è in grado di offrire spazi e opportunità a giovani artisti, favorendo il cambio generazionale nel mondo del teatro e la crescita di progetti a volte anche molto validi e innovativi. È il caso dell’Amleto di CollettivO CineticO: uno show postmoderno giocato sui toni del format televisivo, un talent in cui la posta in gioco è il ruolo del principe danese.  Ancora una volta Amleto è il passepartout dell’animo umano, chiave e chiave di volta di una decostruzione la cui pars construens arriva dal pubblico chiamato a essere giudice tramite applausometro. Come dice il saggio: «L’emendamento delle cose guaste ha sublime riuscita». Purché non si rimanga invischiati nel dubbio amletico, spesso rimproverato ai giovani da palchi importanti dove impazzano attori cariatidei. L’errore di questi interpreti, pur bravi e navigati, è tragico: pur non volendo essi interpretano Polonio che spia Amleto attraverso la tenda, biasimandolo e scambiando per pazzia i suoi tentativi di eludere il suo destino di vendetta. Lo scotto di tale errore secondo Shakespeare è la morte.
Ancora una volta Amleto è il passepartout dell’animo umano, chiave e chiave di volta di una decostruzione la cui pars construens arriva dal pubblico chiamato a essere giudice tramite applausometro. Come dice il saggio: «L’emendamento delle cose guaste ha sublime riuscita». Purché non si rimanga invischiati nel dubbio amletico, spesso rimproverato ai giovani da palchi importanti dove impazzano attori cariatidei. L’errore di questi interpreti, pur bravi e navigati, è tragico: pur non volendo essi interpretano Polonio che spia Amleto attraverso la tenda, biasimandolo e scambiando per pazzia i suoi tentativi di eludere il suo destino di vendetta. Lo scotto di tale errore secondo Shakespeare è la morte.
L’emendamento ovviamente è nel teatro: quello agito per comprendere, vissuto fino in fondo con la consapevolezza di cui era impregnata la penna del Bardo.
[1] William Shakespeare, Amleto, tr. it. di Eugenio Montale, Mondadori, Milano 1988, atto III scena II.
[2] Al contrario di quanto spesso erroneamente si crede, queste parole non vengono pronunciate da Amleto ma da Marcello, una guardia di palazzo. Si racconta che una volta questa battuta fondamentale e piena di pathos fu dimenticata e il celebre attore shakespeariano David Garrick (1717-1779), nei panni di Amleto, decise di improvvisare per compensarne l’effetto: seguì quindi lo Spettro fuori dalla scena, stabilendo un precedente che da allora ha fatto scuola.
[3] Quel Morte di un commesso viaggiatore recentemente riproposto al pubblico milanese da una notevole ancorché leggermente manierista produzione del Teatro dell’Elfo.
[4] Nel 2010 la direttrice artistica del Teatro Ringhiera ATIR Serena Sinigaglia ha provato a rispondere a questa domanda in Di a da con su per tra fra Shakespeare, una conferenza-pièce che riflette, sfruttando con intuito tutti gli strumenti della meta-teatralità, sulle difficoltà di un regista nell’approccio con i classici del teatro.