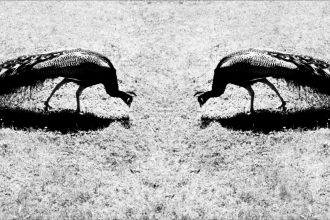Dopo John Cage
Che cosa rimane dopo l’Apocalisse? Vari mondi frantumati ostili. Ciascuno vuole il suo novum e non lo ottiene. All’origine c’è una mezz’ora di silenzio dimenticata da tutti.
(Roberto Calasso)

Dove capita che qualcuno esegua la musica di John Cage, la cosa è spesso accompagnata dall’avvertimento per chi viene a sentire di essere già parte della performance. Tanto che anche arrivare in ritardo raggiungendo rumorosamente il proprio posto in sala, non pare troppo inappropriato. Né rappresenta un’intrusione il cigolio di una porta del teatro, il rumore del riscaldamento o dell’aria condizionata, e nemmeno le temibili suonerie dei cellulari. «Attenti a ciò che è bello da mozzare il fiato, perché in qualunque momento potrebbe suonare il telefono…»: lo diceva ben prima che il telefono lo si iniziasse a portare in tasca.
L’igiene sonora e rituale nella sala da concerto è un carattere fra i tanti che possono mostrarsi, anche simultaneamente: tutti, incondizionatamente, ben accetti.
La situazione: gli esecutori leggono ad alta voce le indicazioni sulla partitura, fra cui la libera partecipazione, senza indicate limitazioni, del pubblico alla performance.
Fra chi assiste, le idee su cosa fare sono innumerevoli, ma in mancanza di un carattere estroverso, i più restano tranquilli. Si gode di un’ora, o anche più, di azioni senza scopo all’infuori del loro rappresentarsi, appunto, senza scopo. Nessuna protesta, nessun radicale sconvolgimento delle prospettive personali. Forse, il seme gettato di un’incertezza, ma uno fra i tanti che la vita deposita con monotona indifferenza. Il ritorno a casa avviene senza turbamenti.
Il 2 dicembre del 1977, qui a Milano, il compositore in persona incontra ben altra accoglienza, per sé e per la sua arte. Basta cercare: le immagini parlano da sole. La RAI ne fece un servizio che si reperisce facilmente, con tanto di interviste ai ragazzi fuori dal liceo Leonardo e qualche parola di Franco Battiato al microfono, accortamente ben lungi dall’esprimersi sull’imprevedibile.
Cage lo vediamo, sul palco, seduto a uno di quei banchi ai quali siamo stati tutti a scuola, coperto dai segni della noia di generazioni di studenti. Legge sillabe come suoni sconnessi, isolati, a bassa voce al microfono, attorniato nella penombra da chi anziché vinto dalla repulsione, sale su quel palco buio già stregato dal rituale svuotato di ogni senso: il vuoto che attrae.
Durante la performance lo spirito della contestazione va producendo via via un trito clima da guerriglia studentesca, e alla fine l’eroe della serata è fragorosamente acclamato da tutta la platea «come un gladiatore», mentre abbraccia sorridendo i suoi affezionati “disturbatori”.
Mezzo secolo è passato da allora. Sono successe molte cose, ma forse non abbastanza, perché ancora, cosa stava facendo John Cage dietro a quel banchetto di legno sul palco del Teatro Lirico quella sera d’inverno, non l’abbiamo capito tanto bene. Evidente anche solo dal fatto che abbiamo del tutto metabolizzato l’esperienza senza accorgercene.
Arnold Schönberg, stando a quanto racconta Cage stesso, l’avrebbe definito «più un inventore che un musicista». Inventore della musica del silenzio, e dell’idea di infilare articoli da ferramenta o da cartoleria fra le corde del pianoforte. Durante gli anni della guerra che devastava l’Europa lavorava a trasformare la digitalità della tastiera in un mezzo capace di perforare la barriera che separa dal suono reale, quella barriera che la tastiera (qualunque tastiera) intrattiene con il mondo materiale ponendo sotto le dita un esercito di parificate corrispondenze.
Prima di allora le percussioni erano state il mezzo prediletto di Cage per evadere dalle costrizioni del suono intonato, dalla sua purezza ascetica, dal regale distacco dalla materia più grezza, materia che è la pasta di cui è fatto il mondo.
E mentre qui da noi si perforava con l’artiglieria, con i boati assordanti delle bombe e dei crolli, dall’altra parte dell’oceano il suono indeterminato, il rumore, dal roboante set di percussioni passava a un ordine di grandezza inferiore; ma soprattutto, di più indeterminate risultanti performative. Nessun pianoforte riprodurrà il medesimo effetto di un altro pianoforte “preparato” secondo le stesse prescrizioni. Le varianti sono troppe. E proprio questo iniziava a piacergli.

Dopo la fine della guerra alcuni compositori si posero in pochi anni alla guida di un movimento musicale ricordato con l’espressione dal sapore tutt’altro che disteso di “serialismo integrale”. Il quartier generale di questa avanguardia post bellica, i corsi di Darmstadt, erano seminari estivi tenuti in un paesino della Germania Ovest riqualificato come centro della cultura musicale mondiale.
Cage era il tassello mancante di una storia che rischiava di incancrenirsi per sempre. In questa storia, se lui fu cavaliere della distruzione fra le mura del barricato “strutturalismo” di Darmstadt, Pierre Boulez, intelligenza fra le più lungimiranti del suo tempo, lo possiamo ricordare oltre che come suo illustre predecessore, anche come indispensabile scudiero, cosciente, nella sua iniziativa di introdurre Cage fra i compositori di Darmstadt, di star immettendo nell’ordine dogmatico dell’ormai addomesticata avanguardia «un po’ di disordine, qualcuno capace di demolire i dogmi».
Boulez, francese isolato dal neoclassicismo tradizionalista dei suoi connazionali, si era spinto nel tentativo di essere quanto più estremo, raggiungendo i «confini della terra fertile» con la sua musica costruita su rigide tabelle numeriche capaci di assicurare l’assoluta disumanità del prodotto finale.
Aveva distrutto, sì, ma per creare spazio. Ora è ricordato perlopiù per quella pars destruens, più grottesca rispetto ai successivi lavori nei quali cercò «la libertà, il respiro»; quel respiro a cui la musica di Debussy aveva aperto la strada all’inizio del secolo, insieme ai suoni e ai ritmi della musica extraeuropea, extra colta, o precedente alla scrittura per parametri.
John Cage, dall’apparenza più bonaria, segue invece la parabola opposta, e di quello che c’era prima del suo passaggio ha lasciato solo l’involucro.
Ad oggi, anche senza saperlo, viviamo le conseguenze di una detonazione silenziosa: conseguenze analoghe a quelle di una «rivoluzione del silenzio» che Cage auspicava per gli Stati Uniti nel discorso che tenne a scuola quando aveva 15 anni: un silenzio collettivo che abbracciando tutte le attività politiche, produttive (e distruttive) avrebbe portato idealmente a riconoscere l’America come «una nazione fra le nazioni», così come ora siamo costretti a guardare alla cosiddetta “musica d’arte” come a “un genere fra i generi”, con gli stessi stereotipi che assorbono tutto il ventaglio di scelte estetiche dell’ascoltatore.
E gli stereotipi sulla “musica classica” non sono meno pervasivi dei pregiudizi che si coltivano nell’accademia, costretta a essere sempre più inclusiva, se non promiscua. Salvo mode fortunate, nessuna aderenza a tradizioni gestuali ha più alcuna sopravvivenza all’infuori di circoli sempre più ristretti di partecipanti, circoli che si stringono come un cappio attorno a chi resiste, chiuso all’interno.

Ce n’è per tutti i gusti: «any color you like», e nessun colore gode sugli altri di un’autorità superiore a quella di una stagione della moda sulle altre. Si badi: l’eccezionalità del momento non sta nella sua impermanenza – sorte delle cose che sono passate, tutte, sotto lo stesso sole – ma nella rivelazione nascosta, fatta detonare a poca distanza dalla stagione degli orrori dell’occidente, dell’ipocrisia di qualunque ritualità rivolta al sogno di un presente o di un futuro radioso, speranza agli occhi del secolo irrimediabilmente svuotata – maschera di altri nascosti guadagni e sperperi senza benefici.
Riguardo al suo brano più noto, 4’33’’, del 1952, provocatorio invito all’ascolto del “silenzio” all’interno di una sala da concerto, alla domanda su cosa avesse imparato dal “grande dibattito” che aveva fatto scaturire non rispondeva volentieri parlando di imparare. A lui interessava «come le cose cambiano». E come lo aveva cambiato la risposta alla sua “musica”? Come ci ha cambiato? «We have less confidence now in time as it goes into the future. We wonder for instance, how long the future will be: we don’t take for granted that it will be forever.» Quasi a parlare, oggi come allora, fosse un’eco dell’ultimo, tremendo, atto della guerra.
Fra il pubblico del Teatro Lirico, quella sera del 1977, c’è anche Roberto Calasso, lo storico direttore della Adelphi, che un paio di settimane più tardi pubblica un articolo su Panorama, in cui oltre a recensire il concerto, in poche mirate analogie tratteggia una prospettiva più lucida di quanto non sia più dato cogliere, diluita ormai l’esperienza, nella distanza del tempo.
Fra quelle righe, tese all’inverosimile, Calasso, attraverso un’immagine sonora – omaggio sottile – affianca John Cage, «l’illustre musicista», a una figura che fa la sua comparsa nei suoi scritti venti anni più tardi: «L’invincibile risata che ha un rumore di foglie secche», si aggiunge alle stranezze dell’aspetto di Cage e ritorna fra i tratti del «terrorizzante, impenetrabile» brahmano Durvāsas della mitologia vedica, il quale si dice essere «una porzione, una scheggia, un tizzone di Śiva».
Quando Durvāsas compare è per assicurare alla vita il suo infallibile anatema, chi lo riconosce, lo accoglie con ospitalità, temendo riverente la sua presenza nefasta.
Così John Cage, questo signore un po’ buffo dai modi bonari, ci assicura, nella sua comunione con l’essenza dei suoni del mondo che il suono più bello è quello del silenzio e che «il silenzio oggi è il traffico»: quel traffico che impercettibilmente stritola la vita degli esseri umani nella conurbazione e nelle prospettive inarrestabili dell’apocalisse climatica. Mentre la strada gorgoglia come la corrente di un fiume, questo simpatico vegliardo dalla reputazione di inguaribile dadaista ne contempla la voce, seduto alla finestra del suo appartamento.

Ma l’aspirazione più cara a Cage, per sua ammissione, era proprio quella verso la poesia: niente di suo ha goduto di più attenzione del libro che raccoglie i suoi scritti, Silence, e in tutta la sua opera si riconosce la devozione per il potere sonoro della parola.
Empty words, con cui parve giocare a far ammattire il pubblico milanese al Teatro Lirico, era un anatema di sillabe scomposte, pronunciato sommessamente, con lo scopo di conferire ad ogni nostra certezza l’impressione della sua caducità.
di Alessandro Guarneri
LEGGI TUTTI I NOSTRI ARTICOLI DI MUSICA