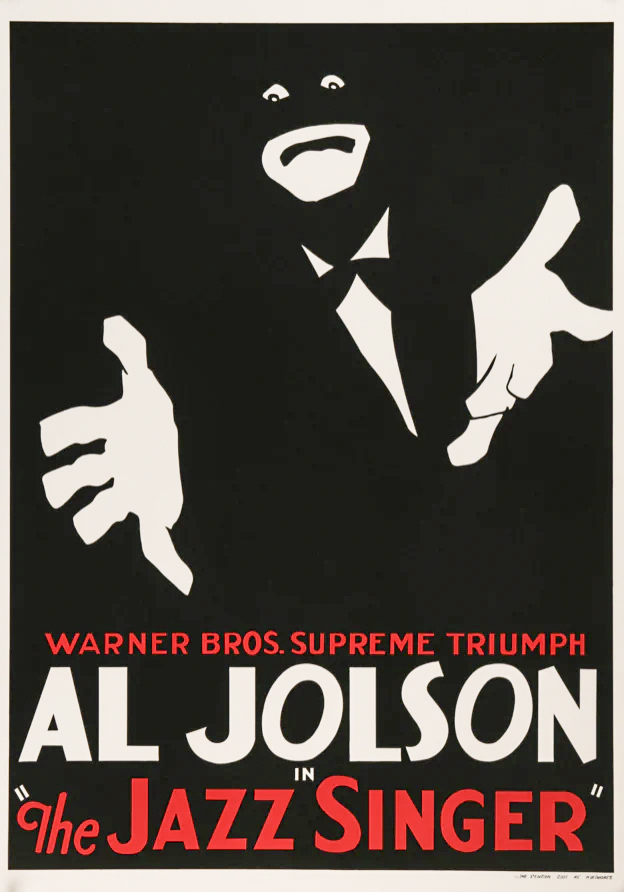L’invenzione dei pellegrini combattenti

Il pellegrinaggio è una pratica religiosa estremamente comune, da Međugorje alla Mecca, come da Lumbinī all’isola di Shikoku. Se, dall’età periclea al patriarcato di Michele I Cerulario, l’Athos ha soppiantato l’Olimpo, una mèta di pellegrinaggio ha comunque continuato a esserci e a fungere da centro sia devozionale, sia economico-politico. Tuttavia, è stato solo il cristianesimo a concepire un pellegrinaggio penitenziale di stampo bellico, incarnato da monaci combattenti organizzati come un esercito.
Naturalmente, vi sono stati vari monaci armati nella storia, basti pensare agli adepti dello Shàolínquán buddhista cinese o al sikhismo indiano, il quale prescrive il possesso rituale del pugnale kirpān per tutti gli adepti e certamente il loro uso non è sempre stato esclusivamente simbolico. Le spade del medioevo europeo avevano spesso proprietà mistiche, al pari del daishō nel quadro dello shintō giapponese, perché si trattava di strumenti consacrati nella dialettica di brutale sottrazione e poetica protezione della vita tipica delle armi bianche.
La legittimazione dell’omicidio è sempre stata oggetto di complesse discussioni etiche, normative e dottrinali. Il cuore del Mahābhārata consiste nella rivelazione, offerta da Viṣṇu-Kṛṣṇa al principe Arjuna, della possibilità di essere un armigero yogico il cui agire violento è un sacrificio compiuto senza animosità, nel nome del puro dovere. Una giustificazione fondamentale per un sistema religioso nonviolento che doveva integrare una casta guerriera.
Può avere perfettamente senso che un soldato venga investito di prerogative e doveri sacri, ma nel mondo cristiano dell’anno Mille vi erano pochi presupposti perché questo fatto generico si traducesse in una radicale giustificazione della guerra. Malgrado il pacifismo radicale del paleo-cristianesimo fosse stato superato dalla realpolitik dei vescovi che avevano scelto di scendere a patti con le autorità imperiali per sdoganare il culto, malgrado Carlo Magno avesse reso i franchi la mano armata della Chiesa e malgrado l’accumulo di tensioni e ambizioni che produssero il Grande Scisma del 1054:
l’idea che i migliori cristiani fossero i monaci e che costoro non potessero ricorrere alla violenza in nessun caso era rimasta dominante.
Molti abati detenevano un peso politico e una ricchezza principesca e i loro ordini gestivano porzioni significative della vita pubblica nei rispettivi territori di pertinenza, eppure il loro compito principale restava la conduzione di una vita contemplativa, lontana dalla mondanità gestita da preti e laici.

I monasteri erano i bastioni eretti contro Satana. La mera presenza di uomini dediti a Dio e privi di interesse per la mondanità era considerata capace di stornarne l’influenza da intere regioni.
Questa battaglia metafisica era del tutto distinta da quelle terrene e la gente non avrebbe mai immaginato di dare una spada a un monaco, perché le sue armi erano le uniche considerate capaci di sgominare le legioni infernali: le reliquie, i libri, i simboli sacri, l’astinenza, il canto e soprattutto l’incessante preghiera.
La violenza rimase a lungo, di principio, una colpa.
Qualsiasi nobile cavaliere era chiamato a confessarsi e pentirsi il più spesso possibile, onde evitare la dannazione. Agli occhi dei grandi teologi della patristica, come Agostino d’Ippona che pure si era speso per dimostrare la possibilità di una guerra giusta, l’ipotesi di una guerra santa combattuta da monaci armati sarebbe apparsa eretica.
A cambiare la prospettiva fu anzitutto la Reconquista, il lunghissimo braccio di ferro tra musulmani e cristiani per il possesso della penisola iberica che si era sviluppato intorno al X secolo, ma anche con il trionfo letterario della chanson de geste che vedeva nel cavaliere cristiano un testimone della fede e un potenziale martire, sebbene morisse combattendo e non accogliendo passivamente la propria sorte. A questi fattori va aggiunta la generale disgregazione che stava colpendo sia il mondo cristiano, sia quello musulmano.
In entrambe le fazioni non vi era più un’unica leadership pressoché incontestata, com’era accaduto al tempo di Carlo Magno e di Hārūn al-Rashīd.
Vi erano, invece, tanti signori che si litigavano costantemente le risorse e i territori, facendo dilagare la violenza e il sospetto.
Nel mondo arabo erano sopraggiunti i turchi ed erano rapidamente diventati la nuova élite, con grande scorno della precedente.
Per i pellegrini occidentali disarmati era diventato oggettivamente più difficile andare in visita al Santo Sepolcro, inoltre l’Europa poteva trovare nell’infedele un bersaglio esterno sul quale deviare la brutalità del ceto cavalleresco, flagellato anche dalla piaga dei secondogeniti costantemente in cerca di un riconoscimento che potevano ottenere solo con imprese militari e matrimoni vantaggiosi.
In Europa, d’altronde, la popolazione stava aumentando ed era giovane.
La cristianità era in grado di mobilitare una grande massa conquistatrice, guidata da nobili senza terra che speravano così di ottenere tanto la beatitudine per la propria anima, quanto un regno da governare. Faremmo dunque un errore a credere con Voltaire che i crociati fossero vittime di un idealismo cieco, data l’estensione notevole dei regni che crearono in Medioriente, ma sarebbe altrettanto sbagliato allinearsi con la storiografia ottocentesca che riduceva l’intera faccenda a motivazioni politiche e proto-colonialiste. Del resto, dopo la disfatta bizantina a Manzikert del 1071, l’Anatolia stava venendo rapidamente conquistata dai musulmani che non avevano mire espansionistiche inferiori a quelle cristiane.
Il concilio di Clermont del 1095 scaturì da questioni complesse che esigevano un confronto tra laici ed ecclesiastici. Era in atto la riforma cluniacense e re Filippo I di Francia, già sposato con Berta d’Olanda, aveva rapito Bertrada di Montfort, moglie di Folco IV, conte d’Angiò, e ne aveva fatto la propria seconda moglie. Papa Urbano II lo scomunicò, ma, nel contesto di questo grande sinodo, decise altresì di rispondere pubblicamente alla lettera ricevuta dal Βασιλεύς Alessio I Comneno: Bisanzio chiedeva aiuto contro l’avanzata selgiuchide, giunta ormai alle proprie porte.
Roberto il Monaco riporta il discorso del papa nel suo Historia Hierosolymitana e in esso spicca l’inedita associazione tra i pellegrini comunemente intesi e chiunque fosse andato a combattere per liberare loro il passaggio.
L’iniziativa di Urbano II era in linea con quella politica, già gregoriana, che voleva fare del papa l’uomo più potente dell’Occidente, posto da Dio al di sopra dei sovrani laici.
La lotta per le investiture era iniziata nel 1073 e la Chiesa l’avrebbe vinta nel 1122, con il concordato di Worms.
Le crociate dimostrarono che il papa fosse l’unico in grado di ottenere consensi continentali e indirizzare verso un unico obiettivo una tale quantità di uomini e mezzi. L’entusiasmo per le crociate, tuttavia, si sarebbe sempre progressivamente spento proprio a causa della tracotanza con cui i papi le avrebbero poi bandite non solo contro i presunti rivali della cristianità, ma anche contro gli eterodossi e i propri nemici politici, soprattutto se imperatori decisi a far valere il proprio primato in un’ottica ghibellina.

La conquista di Gerusalemme del 1099 ebbe una ricaduta talmente forte sull’immaginario europeo che lo scontro con il mondo musulmano vi si configurò come un aspetto ovvio della cavalleria, al punto che solo nel Seicento la cosa iniziò a essere messa seriamente in discussione: ancora nel 1581, quasi mezzo millennio dopo, Torquato Tasso pubblicava la Gerusalemme liberata.
Nuovi nobili penitenti, foraggiati dalle donazioni dei simpatizzanti, si mossero in un flusso costante che mirava a consolidare la presenza cristiana nei territori conquistati e difenderli dalla controffensiva islamica. Quando il cavaliere francese Hugues De Payns, intorno al 1120, decise che lui e i suoi pari avrebbero dovuto poter ottenere lo statuto monastico per il servizio che rendevano a Cristo, s’insediò nel Tempio di Salomone e proclamò la nascita dei templari, chiedendone il riconoscimento nel 1129.
Vi furono accesi dibattiti tra i suoi simpatizzanti e i frati tradizionalisti. San Bernardo di Clairvaux, intorno al 1135, pubblicò il decisivo De laude novæ militiœ ad Milites Templi. L’opera pose i templari allo stesso livello degli altri ordini monastici e ne legittimava l’aspirazione alla santità, sottolineando la differenza tra i vecchi guerrieri, alla cui classe sociale era appartenuto egli stesso e che aveva sempre accusato di crudele vanagloria, e questa nuova generazione di combattenti che si spendeva per il trionfo del Verbo.
La sua concezione ricorda da vicino quella enunciata da Kṛṣṇa nell’epopea hindū: i templari uccidono e si fanno uccidere con animo sereno e distaccato, liberi dall’odio e dalle brame terrene. A suo avviso, essi non commettono alcun omicidio e quindi non violano il quinto comandamento, ma si limitano a compiere un doveroso malicidio, ovverossia l’eliminazione dei malvagi al solo scopo di prevenirne i peccati e di lenirli con una fine accolta a titolo di riparazione.
Sdoganata la possibilità di essere a un tempo pellegrini, combattenti e persino monaci, i cavalieri cristiani si interessarono sempre più a questa possibilità di carriera.
Fomentato dai cluniacensi e dai re asturiani e leonesi, si consolidò anche il pellegrinaggio a Santiago di Compostela, di fatto un servizio militare volontario prestato contro il califfato di al-Andalus. Era nato il mito di San Giacomo Matamoros che trasfigurava l’apostolo in un cavaliere redivivo, postosi alla guida dei cristiani contro gli infedeli nell’immaginaria battaglia di Clavijo. Favole e verità si mescolarono, fondando un aspetto essenziale della nostra contraddittoria identità, sospesa tra cinismo e cavalleria, fanatismo e tolleranza, unità e disgregazione.
di Ivan Ferrari