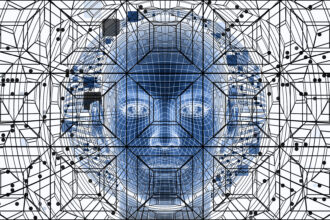Poco mi serve.
Una crosta di pane,
un ditale di latte, e questo cielo
e queste nuvole.
(Velimir Chlebnikov)
CAPITOLO III – Spas [Спас ]
Stazione di Moskovskij Vokzal, treno n. 227 delle 12:11. Appena sotto la scritta “Платформа” la casella sembra vuota. Indosso gli occhiali e guardo meglio. È proprio vuota. Aspetto fino alle dodici in punto ma il binario non compare. Vado fino alle banchine e lì lo trovo. Il mio treno.
I letti su due piani e l’impressione degli sguardi che scoccano da ogni anfratto come di notte in un bosco mi riportano sui treni indiani. Lì ero la persona meno sudata, maleodorante e stravaccata della carrozza, mentre qui i posti sono occupati da gentili signore, bambini tranquilli e uomini stesi in silenzio. Il solo gesto di togliersi le scarpe e arrampicarsi come un geko sembra quasi fuori luogo, eppure non c’è altro modo di raggiungere il proprio cantuccio montano, che per risparmiare si è acquistato un upper seat.
Da lassù si domina la scena. Diventi uno di quegli stessi occhi ignoti, vindici contro i futuri passeggeri, brillanti nel buio, che sbirciano di nascosto da quella finestra in alto come nelle icone russe, dove confinano il Padre perché non interferisca troppo con la sfilata dei santi o le pose della Vergine.
Sì, mi sento di nuovo in India. E ancora il vagone si trasforma in una piccola casa, non un ashram stavolta, ma una izba, dove tutti finsocono per conoscersi e tessere nella trama di un grande drappo fatto di sguardi un vestito di sarafan. In questo colore multietnico riconosco le giovani pietroburghesi che fingono di non sentirsi le più contemplate, vedo le famiglie moscovite tornare nelle case avite, e nell’attesa i bambini zompano fra i letti del treno. Sullo sfondo compaiono i primi volti d’ottone assaggiati sulle guance dal cucchiaino delle terre dell’Est.
C’è sempre un controllore per ogni vagone, e con lui la piccola comunità può giovare del suo batiuška. Oltre a chiedere i biglietti, a espropriare il passaporto, distribuisce anche tè in buffe tazze di vetro circonfuse da una maschera di metallo con rilievi decorati in forma di foglie. Per l’acqua ci si serve da soli presso il grande “samovar” ferroviere agli angoli in fondo alla carrozza.
Il nostro baty si dev’essere convinto che per tradurre il russo basti parlarlo lentamente. Appena può intavola con me un sinodo a senso unico così mi tocca ancheggiare per assecondarlo mentre schivo i suoi agguati e mi chiedo cosa sia meno scortese. A un tratto, una ragazza gli fa un paio di gesti e battezza il suo silenzio. L’avevo già notata entrando perché era una delle poche persone rimaste sedute vicino al finestrino senza reclinarsi indietro, ma davanti, sempre china sul foglio, come la curva di una delle sciabole esposte nella sala d’armi all’Ermitage. Con la penna fuori dal fodero era intenta a fendere la carta esangue d’inchiostro.
«Spasibo», dissi andandoci cauto sull’ultima vocale, ancora in dubbio se trattarla come “o” oppure “a” o come ibrido muggito montanaro. Lei, in compenso, non mi aiuta a ricordare come si verseggia il “grazie”, ma opta per un altro gesto tacito in cenno di risposta. Chissà forse aveva capito che non ero russo e che, soprattutto, parlare piano non basta per tradurre la propria lingua?
Il treno intanto era ripartito da un po’. La luce esterna aveva ripreso a danzare e mi riportava spesso lo sguardo su di lei. Aveva la pelle imperfetta e gli occhi un po’ troppo vicini, ma i capelli biondi più alti delle spalle abbracciavano molto bene il viso e la sua posa timida non poteva contraffare il segreto della giovinezza chiuso a chiave nel suo corpo.
Che voglia di parlarle, ma la pigrizia in me si tingeva d’imbarazzo per poter sopravvivere più istanti possibile. Un colpo di sonno del sole rosso dietro le palpebre della conifera fuori dal finestrino e la messa in pericolo della mia curiosità a darle la sveglia.
«Vivi a Mosca?», chiedo di rutto. Senza gli occhi dal foglio alzare, scorre qualche pagina. Si rimette a scrivere. Subito si interrompe e mi rivolge il quaderno.
«No, vengo dalla Siberia», si staglia sulla pagina bianca. Il suo sorriso sospeso mi concede un’ipotesi. Frugo nello zaino e trovo la mia matita.
«Sei muta?», scrivo poco sotto. Stavolta non ha bisogno di scrivere niente. Basta annuire. «Posso indovinare ancora?», aggiungo. Mi guarda stranita, usando le sopracciglia per avvicinare gli occhi, quasi a più non posso.
Sorrido e proseguo: «Stai scrivendo una storia…».
«Perché ti interessa?», esplicita per lasciare implicita la risposta.
«Anch’io sono qui per questo».
Sopra la strana scacchiera su cui mi ero posato atterrando a Pietroburgo era toccata ora un’altra mossa. Ragazza scrittrice e muta in C4. Minaccia alla torre. Si chiamava Sasha, studiava relazioni internazionali ma nel tempo libero curava le relazioni all’interno di sé, componendo piccole storie in russo.
Avevo una diffusa impressione di fatalismo e libertà, come quando si sceglie di muovere l’alfiere: non è obbligatorio, ma se lo si fa occorre spostarlo soltanto in diagonale. Così quegli incontri, a tratti obliqui, avevano una direzione quasi imposta, ma di partenza sembravano il frutto di una libera combinazione, forse legata alla nostra stessa volontà.
«Lo sai che oggi ci sarà un’eclissi?», le ho scritto in uno dei momenti più belli della nostra lunga, intensa e muta conversazione. Lei ha strabuzzato gli occhi e guardato fuori. «Non credo che da qui appaia», ho scritto subito di fianco, «si vede dal mio paese».
Sasha fa uno stacco quasi musicale, poi scrive: «Come due diverse facce della stessa medaglia».
«Come un simbolo», aggiungo io di seguito.
Lei osserva la parola come fosse un’icona e poi scrive lentamente in caratteri cirillici, quasi disegnando, la parola: “метафора”. Dopo averle visto scrivere della sua vita, dei suoi compagni – che lei ha definito poco curiosi – e dopo aver sfiorato argomenti sulla politica del suo paese, decisi di andare fino in fondo.
«Sei disposta a fare un esperimento?».Lei mi squadra incuriosita.
Ci mette un po’ di più rispetto a Diane per capire il senso del mio jeu, sebbene avessi deciso di ometterle il ruolo del mio ospite. Per tirarla dentro del tutto, estraggo il disegno di Diane e glielo posiziono davanti.
«Perché lui le mostra uno specchio?», mi chiede osservandolo.
Ecco che la storia prendeva già altre forme e la tela del dipinto cercava adesso di diventare uno specchio. Per non interferire con la sua ritraduzione mi limitai a rispondere: «Questo devi dirmelo tu».
Lei cambia tonalità al suo silenzio e inizia a riflettere. Dopo un po’ nota: «Lui ha i capelli scompigliati come te».
«Ah sì? Pensa che oggi una signora mi si è avvicinata e ha detto che assomiglio a Gesù»
«Spas», scarabocchia lei poco sotto. Io ondeggio un punto di domanda e allora le incarcera fra due virgolette: “Salvatore”. Ricordo solo allora di aver letto “Спас” al museo sotto il ritratto del Cristo. Riaffianco la penna e ci attacco in coda: «…ibo». Lei sorride.
Il treno intanto inciampa nel buio della sera. Solo un angolo del tavolino rimane illuminato. Io e Sasha ci avviciniamo a quell’isola di luce per continuare a scrivere, nella piccola radura di un silenzioso linguaggio.
«Posso usare un racconto che ho già scritto?».
«Certo, perché?».
«A me questo disegno non sembra affatto allegro», scrive Sasha evocando un’altra trasformazione sulla scacchiera, mentre io pensavo che quel tavolino su cui scrivevamo e su cui avremmo potuto anche giocare a scacchi o fare l’amore in due mosse poteva diventare un letto, cambiare posizione o spargere le pedine delle nostre vite fra le lenzuola di un viaggio.
«Penso che in questo disegno», osa lei giocando con la libertà,«la ragazza si senta in colpa per qualcosa e lui le mette davanti uno specchio per farla osservare».
«E questo ti fa venire in mente una tua storia?».
«È stata quella parola: Спас».
«Hai voglia di scrivermela o sei stanca?».
«No mi va, è la sera giusta. Si intitola: “La vittima e il carnefice”. È molto breve e devo ancora finirla. Anzi, forse tu mi puoi aiutare».
«D’accordo… Spasibo», dissi infine a voce col coraggio di trasformare quella “o” in una “a” per guadagnarmi il sorriso di Sasha prima che lei iniziasse a raccontare…
[***]
– La vittima… –
La follia!… s’impossessa delle persone quando la ragione scompare, direte voi.
Vero?
Immaginate pure di perdere la lucidità, di travisare i rapporti fra le cose. Siete pronti, sta per succedere qualcosa e poi, ecco!… avviene una reazione, guardate:
Causa.
Effetto.
L’avete vista?
Bene, perché io no. E allora… sono pazza. Giusto?
Si crede che quelle come me – una mente, appunto – pian piano si stanchino di fare la guardia. E si pensa che la follia approfitti di questi frangenti per imperversare in casa altrui e mettere a soqquadro tutti quei pesanti mobili, che io e le mie simili abbiamo ordinato in tanti anni.
Tutto falso!… non mi sono mai distratta.
Eppure, lei è arrivata lo stesso. Non me lo spiegavo, l’ho vista entrare con tutto il suo comodo e sistemarsi in pieno agio. Senza che muovessi un dito. Ho ripensato a quanti matti ho incontrato per strada, in vita mia. Camminavano dritti, che buffi! E ricordo che da piccola mi chiedevo: «Come mai non se ne accorgono?».
Poi avrei giurato di no!… per loro era normale.
L’intelletto naufraga, la pazzia finge di farne le veci finché, zitta zitta, la distrazione indugia al punto da vedersi già sfrattata, al solo voltarsi indietro.
– Gli è saltata una rotella! – lo senti?, te lo gridano già tutti.
E che significa, se non che la mente ormai abdica? Senza presagio, spodestata da un io insano, squilibrato.
Intelligenza oppure… dissennatezza, dunque. Dove l’una, l’altra non osa. Aspetta la notte. È come un ubriaco, che riesce a mettersi così in ridicolo, mentre stringe un compromesso con la logica?
– Io mi addormento nell’alcool – propone il cervello, – in cambio, usufruisci della tua “ora d’aria”.
Ssh, è proprio lei: la follia!… fa tante di quelle cose quando la sorella non vigila!
Ma allora, perché io sono diversa?
Come spiegarmi? Diciamo che ho assistito per un po’ alla follia mentre, invece di sgattaiolare silenziosa, come si conviene alla sua vergogna, è entrata con calma dalla porta. Si è quasi, sì: presentata… toc toc!, c’è nessuno?
E non sapevo nemmeno se a stupirmi di più fosse la sua sfacciataggine o la mia inerzia. Non ho reagito, accidenti, non mi sono opposta.
Pigrizia? Paura? O forse… fascino!
Sono corsa dalle amiche a riferire tutto: quasi non mi credevano. Molte di loro, intelligenze solide e fiere, erano pronte ad assicurarmi di non aver mai perso un colpo, né concesso alcun destro alle insensatezze.
Poi, eheh… in privato, si sono confessate: un breve assenza da se stessi, appena un attimo, e zack!… è nata l’incontinenza.
Certo, alla fine mi hanno rifilato una pacca sulla spalla e rassicurato:
– Se non abbassi mai lo sguardo, la follia non comparirà, tranquilla!
E allora? È stata solo immaginazione, la mia?
Cos’è l’immaginazione, vi chiederete? Ah, un’altra parente. Ma da quando si è sposata con la fantasia non è più la stessa, un giorno ve ne parlerò.
E invece: io l’ho vista!, la follia dico: non era fasulla, era proprio lei, ne sono certa!
L’altro giorno, per fare un esempio, ero in ascensore, in pieno possesso di me stessa. Esercitavo la potestà con qualche cenno disinvolto, felice di vedere quanto rispondesse ai miei vaghi desideri. Ma poi: è bastato che la porta dell’ascensore si aprisse e, anziché trovare la via libera, un vicino di casa inaspettato fosse lì, pronto a salutarmi.
Mi sono trasformata. E quella povera persona di cui muovo i pensieri?, è rimasta così: goffa, frettolosa, con la voce rotta a dir cose banali e sciatte, tipo:
– Buongiorno, tutto bene?
Me ne sono pentita subito, ho cercato di rimediare con una battuta improvvisata… Ah!, non è mai quella che spero. Il vicino ha sorriso, io ho contratto le labbra per imitarlo e infine ci siamo allontanati.
È tutto.
– Non ero io, impossibile! – mi sono detta una volta rinvenuta, pur avendo assistito a tutto, – e allora che… sono pazza forse? Sì, sì, certo che sì!… proprio qui volevo arrivare!
Ma, allo stesso tempo… eh!, qui il problema: se sono così capace di capirlo, perché non lo impedisco? I pazzi hanno davvero tutta quest’autocoscienza?
E invece io sì, e proprio io… non ci posso fare nulla.
Il controsenso e il disordine mi battono sempre sul tempo: a ogni frase, su ogni cenno, quasi spostassero all’ultimo la piega dove garba loro, e non dove avevo deciso io. Che fastidio!
Cosa dovrei fare, vivere per un po’ le persone o poi allontanarmene, per timore che abbiano una data di scadenza? Diverrebbero dei mezzi.
Be’! Non sarebbero poche le menti di mia conoscenza a incoraggiarmi, in tal senso. «Avresti una logica ferrea, strumentale, invincibile!», direbbero.
Ma non ci riesco.
Vorrei piangere, ma così… perderei l’identità.
La ragione non piange. La follia lo fa.
Cosa rimane alla ragione allora?… Combattere.
«Va bene allora, coraggio: lottiamo!», me lo sono detta tante volte, senza arrivare neanche a tiro. Io penso e la follia… mi sta davanti. Lei agisce, io osservo. In mezzo: un vetro! L’ho anche toccato, sì… proprio oggi!, con la mano.
Mi trovavo in un posto silenzioso, le luci erano basse e davanti a me stava una donna di mezza età, ancora bella, dalle lunghe vesti bianche. I suoi movimenti erano così lenti… e li descriveva, intanto, mentre io li rifacevo.
Una lezione di yoga, mah!… non guardate me, l’ha suggerito quella là: la follia!, bella al sicuro dietro al suo vetro. Che le importa a lei?
Fatto sta che ogni sabato mattina mi tocca sottostare a un’orgia di gesti strani, insensati. Me ne starei tanto in pace, con un buon libro.
C’è una postura poi, pfui!… “Shavāsana”: che parolone per dirci di rimanere sdraiati supini come un morto, con gli occhi chiusi. Il respiro aumenta e il pensiero decresce.
Inammissibile!
Ed ecco che lei approfitta del sopore e mi compare davanti: la follia!
Energica, quasi rinvigorita dal respiro. Sembra un grosso cervo maschio, adulto e forte, che corre ai margini di una foresta, e mostra i muscoli delle cosce, le volute delle corna.
– È il mio momento: – mi intimo, – devo oppormi!
Compare un treno e io ci salgo a bordo, ma il cervo ci affianca nella sua corsa. Un vetro è sempre lì a separarci, ancora una volta. Il finestrino.
In quel momento, riecheggia un ordine dall’alto: «Frenare i pensieri!».
È il cervello. Provo allora a rimuovere il treno. In fondo stona con la foresta, la natura e tutto il resto. Ma è inutile: non si sposta di un centimetro.
Insorge una voce, da fuori stavolta: «Non cercare di frenare la mente».
È la maestra.
– Ah ottimo, ci voleva! – penso, – posso finalmente allentare la presa.
Ma ecco che arriva un altro comando cerebrale: «Dirigi almeno i pensieri!».
Il treno, nel mio sforzo di rimuoverlo, aveva già allontanato la sua traiettoria, curvandola. Mi tocca prende questa curva e, con l’altra mano, la corsa del cervo. Le accentuo fino a creare due cerchi, verso un percorso stabilito.
Accidenti!… fallisco di nuovo: vanno dove gli pare
Sto per disperarmi, lo sento, ma arriva una voce dall’esterno:
«Abbandona il pensiero, non trattenerlo!».
– E va bene maestra, proviamoci! Ma non credo che senza il mio controllo succederà granché. Avanti, vediamo che sapete fare: tu, treno, e anche quel matto di un cervo… ma come? Impossibile!
Sono scomparsi.
Un momento: ma non è la mente a somministrarci tutti i pensieri? Forse no. Forse siamo noi, sì… soltanto noi!
Io sono solo la vittima di questa follia, di questa persona.
Ma non creda, la vittima, di essere esente dalle colpe del carnefice. L’ha già detto qualcuno, lo so. L’ho studiato. Sono o non sono una mente?
La voce esterna ritorna, per l’ultima volta: «Ora contate undici respiri».
Subito arriva uno stimolo. Mi ordina di obbedire.
Un respiro, due respiri, tre..
«Anzi», aggiunge la voce, «contate da undici a scendere, così la vostra mente si concentra su di un obbiettivo e non vi addormentate».
E va bene: undici, dieci, nove, otto, set…
Sonno profondo.
[***]
La mente parla con se stessa. Si mette in guardia dall’arrivo della follia.
Per tutto il tempo Sasha aveva tenuto di fianco il suo racconto in russo, traducendo direttamente sulla pagina da cui io leggevo. Alla fine presi il foglio per rileggermi tutto e dominare il manto d’inquietudine indossato finché lei scriveva lenta quello strano folle racconto. E intanto mescolavo il tè, nella mia buffa tazza orlata di metallo. Nessun motivo preciso. L’immagine di una nuova Sasha, cinica, consapevole e irrequieta, si rimestava insieme a quella di un vecchio me, cinico, consapevole e irrequieto.
«Adesso tocca alla follia», mi scrisse ghignando nella penombra.
«In che senso?». Ero spiazzato.
«Io ho scritto con la voce della ragione, in prosa. Ma alla fine di quel conto alla rovescia dovrebbe parlare la follia stessa. In poesia, stavolta».
«Al di là della ragione», commentai inutile.
«Esatto… Zaum!».
«Come?».
«Nulla. Solo che non sono tanto per la poesia. Provaci tu».
«E pensi che sia più capace?».
«Tu sei un vero scrittore».
«No, non lo sono».
La notte si alleggerì svuotandosi un po’ nella luce della luna, come un lavandino. Forse era il caso di sciacquare anche il mio debito verso Sasha. Presi il foglio e lasciai uno spazio di tre dita sotto il finale amputato del suo racconto.
Presi a fargli il solletico con la penna…
– …e il carnefice –
Sonno profondo.
…te, sei, cinque, due, quattro, tre
Conto le falcate, e le voci sullo sfondo,
gli echi del bosco, il respiro del ventre.
Lui: mia volontà; loro: i doveri.
Un treno laggiù mi invidia la via,
ecco dov’eri!
È interessante la follia?
Spii ogni gesto, posa o scatto,
che sguardo deduttivo, d’alto rango.
Ma se voglio, anch’io combatto,
poi mi riposo quando piango.
Sono un cervo, dalle vesti bianche.
Mi segue il tuo dissenso,
le gambe mai stanche,
verso il momento meno intenso.
Un ascensore. Che c’è di male?
Ma ha già un odore l’astuzia inflitta.
Be’! So essere banale.
Un sorriso, una minuzia: sei sconfitta!
Corri pure dalle amiche
racconta il tuo peccato,
non ti crederanno: per quanto antiche,
non mi hanno mai guardato.
Ma tu no! Entro e sei lì, sul divano;
mai che i tuoi occhi mi lascino.
Mi nascondo, attendo… invano.
Pigrizia? Paura? No, fascino!
Sfuggirò alla tua gogna?
Ti ho sedotta.
Che vergogna!
Follia la mia condotta.
Sono il carnefice della mente,
una fidanzata illegittima.
Un carnefice non certo esente
dal dolore della vittima.
di Federico Filippo Fagotto
Trovate qui il primo, il secondo, il quarto, il quinto, il sesto, il settimo capitolo e l’epilogo.