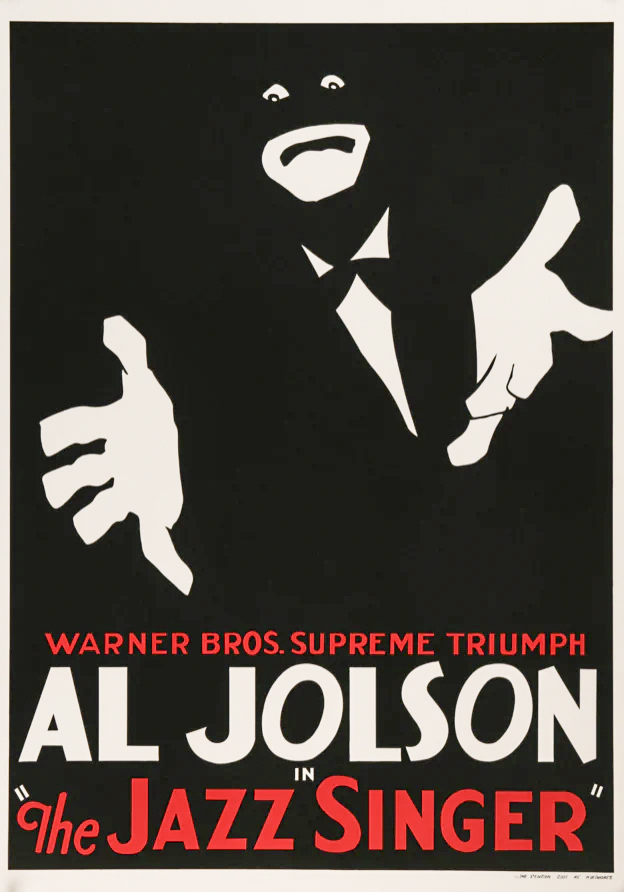di Gabriele Pichierri
///
Quando un esteta, un bullo e un bramino osservante lavorano insieme, le cose possono andare maledettamente male o magnificamente bene. Nella seconda delle ipotesi, alla conquista dei risultati si aggiunge allora l’incantesimo della pura collaborazione.
Il mese scorso ho avuto la possibilità di parlare di una singola grande mente, quella di Poincaré. Questo mese l’I Ching mi suggerisce invece la collaborazione di tre matematici estremamente diversi tra loro, ma uniti dalla loro passione per i numeri, specialmente per i numeri primi, quegli affascinanti “atomi” dell’aritmetica dalle proprietà seducenti ed enigmatiche. Raccolgo l’invito.
L’inglese Godfrey Harold Hardy, conosciuto fuori dall’Accademia per la sua memoria Apologia di un matematico, diede enormi contribuiti alla teoria dei numeri e all’analisi, ma la sua passione era l’ipotesi di Riemann. Formulata dal matematico di Gottinga Bernhard Riemann nel 1859, affermava che una funzione, la funzione zeta di Riemann, avesse la proprietà di annullarsi in determinati punti, ma non è essenziale specificare qui che cosa questo significhi. Tra le conseguenze di questa ipotesi vi era proprio la possibilità di descrivere la distribuzione dei numeri primi. Essa ha guadagnato un’enorme attenzione nella comunità matematica e non solo, soprattutto quando l’8 agosto 1900, al Congresso Internazionale dei Matematici di Parigi, l’influente tedesco David Hilbert la inserì in una lista di 10 problemi irrisolti, estesa poi a 23 problemi. Rimasto ancora un quesito aperto, è stato riproposto nel 2000 come uno dei sette Problemi del Millennio dall’Istituto Matematico Clay, che a differenza di Hilbert promette un premio di un milione di dollari a chiunque fornisca una dimostrazione. La dedizione dello stesso Hardy all’ipotesi di Riemann contribuì a renderla una vera e propria ossessione per innumerevoli matematici. Hardy aveva dimostrato le sue prodigiose abilità e un interesse per i numeri primi già da bambino, quando in chiesa scomponeva i numeri degli inni in fattori primi, e considerava la consultazione dei libri che ne descrivessero le proprietà una «lettura leggera adatta alla prima colazione». Vinse una borsa per il Winchester College nel 1889 e poi una per il Trinity College di Cambridge, che frequentò a partire dal 1896. Ma se da giovane considerava la matematica «in termini di esami e borse di studio: volevo battere gli altri ragazzi, e questa mi sembrava la maniera in cui vi riuscivo con maggior successo», è per la sua eccezionale abilità di collaborare con altri colleghi che ne parlo in questo numero.
Anche John Edensor Littlewood, di otto anni più giovane di Hardy, aveva qualche familiarità con l’ipotesi di Riemann. Cominciò la sua ricerca matematica sotto la supervisione di E. W. Barnes, al quale chiese un problema su cui farsi le ossa durante l’estate. Il tutore gli scrisse innocentemente la definizione della funzione zeta su un pezzo di carta e lo mandò a trovare dove si annullasse, senza comunicargli (forse non sapendolo neanche lui) quale fosse l’importanza del problema. Littlewood non riuscì nell’impresa, ma riottenne il risultato che collegava la funzione zeta ai numeri primi, e ritenendolo inedito scrisse una relazione a riguardo, con la quale voleva guadagnarsi una borsa come fellow al Trinity College. Che Littlewood credesse di aver messo il dito su qualcosa di nuovo la diceva lunga sull’isolamento della matematica inglese, che faceva capo alla disputa tra Leibniz e Newton sulla paternità dell’analisi infinitesimale. Hardy era uno dei pochi matematici inglesi informati sui risultati ottenuti nell’Europa continentale e sapeva che quel risultato non era originale, ma riconobbe le capacità di Littlewood e riuscì a farsi raggiungere a Cambridge nell’ottobre del 1910. I due intrapresero una collaborazione che durò 37 anni, nei quali produssero quasi 100 pubblicazioni. Erano in qualche senso complementari. Se Littlewood, grintoso e robusto anche di costituzione, andava all’assalto di un problema senza farsi troppi scrupoli, Hardy prediligeva la bellezza come «primo criterio: non c’è spazio per della brutta matematica». Harald Bohr, matematico di Copenhagen fratello del Premio Nobel per la Fisica Niels Bohr e amico di Hardy, amava ripetere che in quel periodo «erano tre i grandi matematici inglesi: Hardy, Littlewood e Hardy-Littlewood». Bohr riferisce che il loro rapporto era codificato, come ci si aspetterebbe da due abili matematici, su una base assiomatica:
Regola 1: Non importa se ciò che si scrive l’un l’altro sia giusto o sbagliato.
Regola 2: Non vi è obbligo di rispondere a una lettera, neanche di leggerla.
Regola 3: Va evitato di occuparsi entrambi degli stessi dettagli.
Regola 4: Tutti i saggi scientifici devono portare la loro firma congiunta, a prescindere da chi vi avesse contribuito.
Ovviamente i due facevano sul serio: Bohr racconta che quando Hardy era in visita a Copenhagen raramente leggeva le lettere di Littlewood, a meno che non contenessero qualcosa sull’ipotesi di Riemann. Ancora oggi i matematici parlano di collaborare in base alle regole di Hardy-Littlewood.
Mentre Hardy e Littlewood cercavano di dirimere la questione dell’ipotesi di Riemann, nel 1913 comparvero sulle scrivanie di diversi matematici di Cambridge alcune lettere firmate da un giovane impiegato contabile del porto di Madras, in India, allora una colonia britannica. Il suo nome era Srinivasa Ramanujan. Esse contenevano una carrellata di risultati e formule, alcune delle quali erano note da tempo ma presentate come nuove, altre sembravano cadute dal cielo, senza alcuna giustificazione, altre apparentemente assurde, come 1+2+3+4+… = -1/12. Molti prestarono poca attenzione a queste strane carte. Ma quando Hardy lesse che Ramanujan affermava di aver «trovato una funzione che dà una rappresentazione esatta del numero dei primi» rimase sbalordito. Invitò Littlewood per cercare di capirci qualcosa, e i due si accorsero che quella somma infinita coincideva con un preciso valore della funzione zeta di Riemann. Non poteva essere un caso. Dopo uno scambio di lettere, nel 1914 Ramanujan arrivò a Cambridge, iniziando una delle più grandi e bizzarre collaborazioni della storia della matematica: Ramanujan, privo di un’istruzione tradizionale, era una vulcano di idee, ma non sapeva gestirle con la dovuta precisione; Hardy-Littlewood era il critico che esigeva il rigore matematico. Hardy, ispirato dal classico testo Cours d’analyse del francese Camille Jordan, che lo espose alla più precisa tradizione europea d’oltremanica, era un esteta della matematica, e per lui la dimostrazione era fondamentale. Alla Tavola alta del Trinity College rivolgendosi a Bertrand Russell affermò che se fosse stato in grado di «dimostrare che morirai tra cinque minuti, sarei addolorato per la tua morte imminente, ma il dolore sarebbe mitigato dal piacere della dimostrazione». Tutto il contrario per Ramanujan, che si era impratichito sul semplice testo A Synopsis of Elementary Results in Pure and Applied Mathematics di George Carr, un elenco di circa 4400 risultati classici senza giustificazioni. Hardy diede a Littlewood il compito di illustrare a Ramanujan il rigore della matematica occidentale, ma ciò si rivelò praticamente impossibile. Ramanujan non riuscì mai ad apprezzarne l’importanza: affermava che le formule gli venivano comunicate nel sonno dalla dea Namagiri, protettrice della sua famiglia e consorte di Narasimha, il Dio Leone quarta incarnazione di Viṣṇu. Per lui questo era sufficiente (e necessario: «un’equazione non significa nulla per me se non esprime un pensiero di Dio»). Era stata proprio la dea a convincerlo in sogno a lasciare l’India. Se Ramanujan trovava nell’induismo una fonte d’ispirazione indubbiamente efficace, Hardy fece della battaglia contro Dio una questione personale. In una delle tante cartoline che era solito spedire a colleghi e amici elencò 6 propositi dell’anno nuovo: al primo posto mise la dimostrazione dell’ipotesi di Riemann, al secondo raggiungere un punteggio di 211 (il numero primo immediatamente superiore a 200) ad una partita di cricket, al terzo dimostrare l’inesistenza di Dio. Di certo non gli mancava un irriverente sense of humour tutto inglese, se non a tratti incomprensibile: cercava in tutto i modi di ingannare Dio, sebbene fosse convinto della sua inesistenza. Di ritorno da una visita a Harald Bohr a Copenhagen, il mare che lo separava dal suo ritorno a Cambridge era terribilmente agitato, e allora scrisse a Bohr affermando di aver trovato una dimostrazione dell’ipotesi di Riemann che però era troppo lunga per essere ricopiata sulla cartolina, e si imbarcò confidando che Dio non gli avrebbe concesso di affondare lasciando al mondo l’impressione di aver compiuto l’impresa.
Nonostante le differenze, Hardy, Littlewood e Ramanujan furono gli autori di svariati risultati e di idee che alimentarono le ricerche di intere generazioni di matematici. Ramanujan divenne membro della Royal Society e fellow del Trinity College, ottenendo il riconoscimento tanto desiderato. Purtroppo furono i suoi problemi di salute a terminare il rapporto che Hardy definì «l’unico incidente romantico della mia vita». Non seppe adattarsi al clima rigido, alla dieta (era vegetariano) e alla vita di Cambridge, ma anche nella malattia Ramanujan era capace di acchiappare dall’etere le sue relazioni numeriche. Mentre era ospite in una casa di cura per superare la depressione che lo aveva quasi portato al suicidio, Hardy gli riferì il numero del taxi con cui era arrivato a fargli visita: 1729. Al matematico inglese non sembrava di particolare interesse. «No, Hardy! È un numero molto interessante. È il più piccolo numero che si può esprimere in due modi diversi come la somma di due cubi!»1. E aveva ragione: 1729 = 1³ + 12³ = 10³ + 9³. Un numero che abbia questa proprietà viene oggi chiamato Taxicab Number, proprio in onore di questo episodio2.
La morte di Ramanujan, il 26 aprile 1920, fu un colpo per Hardy, che cadde in depressione e arrivò egli stesso vicinissimo al suicidio. Segnato dalla vecchiaia, non trovava rimedio neppure nella matematica, che «è un esercizio creativo e non contemplativo, e nessuno ne può trarre gran sollievo quando ha perduto il potere o il desiderio di creare». Ma se vi era una consolazione, essa era la capacità di collaborare con un amico, la scoperta di un genio che sarebbe altrimenti andato perduto, la consapevolezza di aver «collaborato con Littlewood e Ramanujan quasi su un piano di parità».
Note
1. Un numero c è detto un cubo se è uguale ad un altro numero a elevato alla terza, ovvero c = a · a · a = a³.
2. Questi numeri hanno fatto il loro ingresso addirittura nel cartone Futurama (vedi).