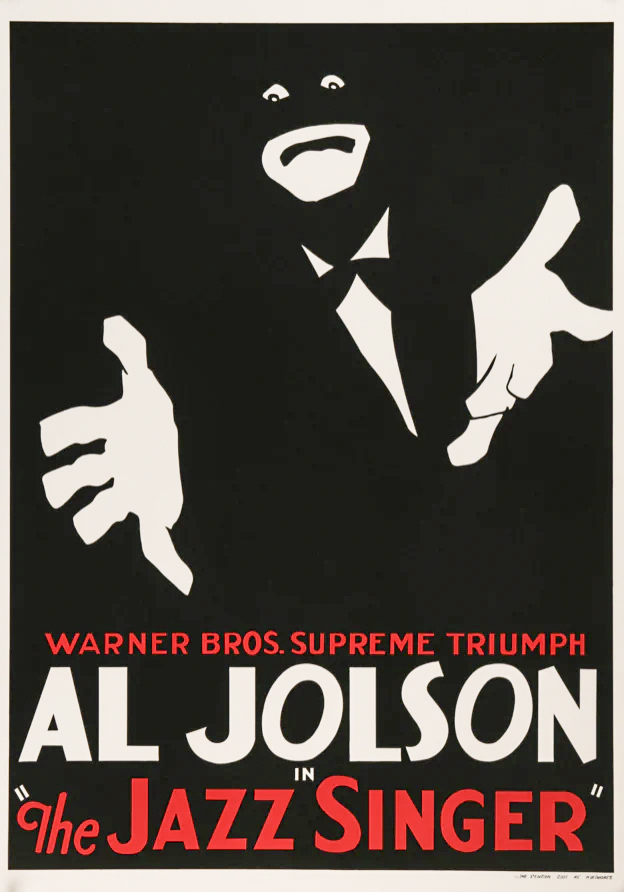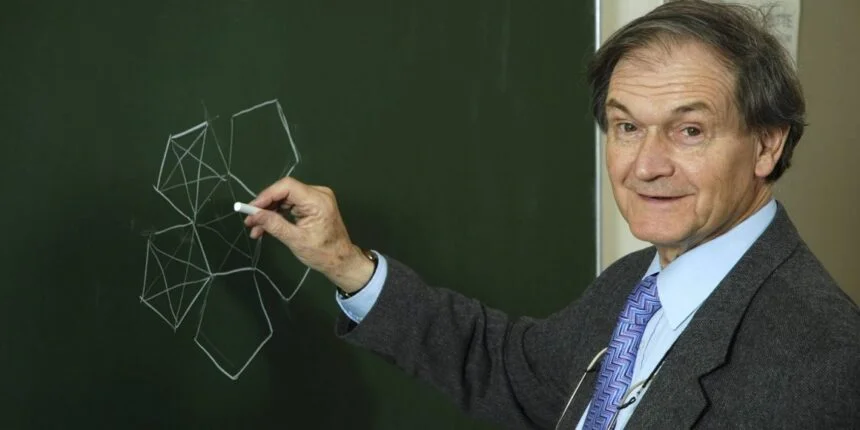L’abbondanza di luce e il pozzo del buio
Siete mai stati in una stanza buia con la luce accesa? Nessun refuso o errore di stampa: mi riferisco proprio a una stanza che resta buia pur essendo piena di lampadine accese. Sono consapevole di descrivere una situazione all’apparenza del tutto paradossale ma posso assicurarvi che in realtà costituisce la quotidianità di ognuno di noi: non è forse vero che l’Universo riporta un’enorme abbondanza di stelle, pur rimanendo in un pozzo di buio?
Qualcuno potrebbe obiettare che il cielo non è buio, bensì blu o azzurro, ma io ribatterò a mia volta che in realtà il cielo non è affatto azzurro. Quel che succede, invece, è che durante il dì la luce solare penetra nell’atmosfera terrestre, che possiamo immaginare composta da tante minuscole particelle; nell’attraversare gli strati dell’atmosfera, la luce si scontra con queste particelle e in base alle loro dimensioni si muove come in un flipper. Nel 1666, Isaac Newton aveva notato che facendo passare un raggio di luce bianca (come quella solare) in un prisma, questa si scompone in un arcobaleno di colori[1]. Tale fenomeno indica che la luce solare è dunque composta da diverse radiazioni (diciamo pure colori), caratterizzate da specifiche lunghezze d’onda. Nel muoversi attraverso l’atmosfera, non tutti i colori che compongono la luce solare si comportano ugualmente: quella parte dello spettro di luce caratterizzata da lunghezze d’onda più grandi (approssimativamente la parte rossa, arancione e gialla) riesce a superare gli “ostacoli” che incontra sul suo cammino e a proseguire nella propria traiettoria rettilinea; al contrario, la luce blu (che ha una lunghezza d’onda inferiore) viene diffusa in tutte le direzioni, diventando il colore predominante del cielo.
E al tramonto invece cosa succede? In questa fase della giornata, la posizione del Sole all’orizzonte è tale per cui la luce attraversa uno strato di atmosfera più spesso: il fenomeno di diffusione raggiunge così un caso limite in cui la componente azzurra è dispersa completamente e la sua intensità risulta trascurabile rispetto a quelle rosse, che non vengono deviate. Ovviamente, se la Terra fosse sprovvista di atmosfera, non ci sarebbe nessuna particella a deviare la luce: non solo non vedremmo i colori del tramonto ma anzi il Sole ci apparirebbe costantemente come una sfera bianca in mezzo a un cielo completamente nero.
Dopo il tramonto, il cielo torna scuro: quando una faccia della Terra non è colpita dai raggi del Sole, non c’è alcuna diffusione di luce in atto. Nel buio, riusciamo a distinguere così la luce degli astri e dei vari corpi celesti che si possono osservare. Almeno una volta nella vita, un po’ tutti ci saremo chiesti col naso all’insù: ma le stelle quante sono? La domanda mi ricorda un passaggio di Borges:
Chiudo gli occhi e vedo uno stormo di uccelli. La visione dura un secondo o forse meno; non so quanti uccelli ho visti. Era definito o indefinito il loro numero? Il problema implica quello dell’esistenza di Dio. Se Dio esiste, il numero è definito, perché Dio sa quanti furono gli uccelli. Se Dio non esiste, il numero è indefinito, perché nessuno poté contarli.[2]
Per quanto riguarda le stelle, qualcuno ci ha provato. Lo scorso anno si è arrivati a stimare l’esistenza di duemila miliardi di galassie[3], un ordine di grandezza superiore rispetto alle stime precedenti. Ricorrendo a nuovi modelli matematici, gli scienziati hanno infatti stimato un certo numero di galassie che l’attuale generazione di telescopi non è ancora in grado di osservare.
Eccoci così al paradosso che suggerivo all’inizio: se si può ipotizzare l’esistenza nell’Universo di duemila miliardi di galassie, ciascuna con almeno qualche centinaio di milioni di stelle più o meno luminose, come si spiega il nero dello spazio? Il cielo dovrebbe piuttosto apparirci luminoso, o no? Questa domanda è tradizionalmente attribuita all’astronomo tedesco Heinrich Wilhelm Olbers (1758-1840) e alcune ricerche attuali, come l’articolo citato, cercano tuttora di fornire risposte a questo interrogativo. Generalmente verrebbe da rispondere che le galassie e le stelle più lontane da noi appaiono più fioche e quindi non sono in grado di illuminare il nostro cielo. A conti fatti, in realtà, la distanza delle stelle risulta ininfluente nel calcolo nella luminosità media misurata di una porzione della sfera celeste. I fattori che subentrano sono ben più complessi; uno su tutti è legato all’espansione dell’Universo: le galassie e le loro stelle si muovono allontanandosi da noi e il loro moto di recessione implica anche una transizione del loro colore verso il rosso (redshift)[4], allo stesso modo in cui il suono della sirena di una ambulanza cambia mentre si allontana da un osservatore. Se il redshift è abbastanza grande (dipende dalla velocità di recessione) può anche succedere che la luce emessa dalla galassia esca dalla regione visibile dello spettro elettromagnetico, impedendone l’osservazione con telescopi ottici.
Non è poi da trascurare il fatto che la luce ha una velocità finita: guardando il cielo, non assistiamo a una “diretta”, ma… guardiamo il passato. Se in questo preciso istante Betelgeuse (una supergigante rossa nella costellazione dell’Orione, facilmente osservabile a occhio nudo in inverno) esplodesse in una supernova, il primo fotone dell’esplosione arriverebbe ai nostri telescopi fra più di 600 anni[5]. In questo senso, possiamo definire attorno a noi una sfera con un raggio pari a 14 miliardi di anni luce (l’Universo osservabile, dove 14 miliardi di anni è l’età dell’Universo) da cui riceviamo luce, ma nulla possiamo vedere oltre i bordi di questa bolla. Se consideriamo poi che le stelle hanno a disposizione una quantità finita di energia e seguono un loro processo di evoluzione (non possono emettere luce per sempre), man mano che le galassie più lontane ci fanno avere notizie di sé, galassie più vicine inizieranno a “spegnersi”: l’effetto finale sarà quindi che è per noi osservabile solo un numero limitato di galassie e quindi di stelle.
Non posso esaurire qui tutte le risposte che son state fornite nel tentativo di confutare il quesito di Olbers. Forse, di fronte alla straordinaria abbondanza di stelle nel cielo, potrebbe bastare piuttosto la filosofia che Calvino suggerisce per bocca del signor Palomar:
Quando c’è una bella notte stellata, il signor Palomar dice: – Devo andare a guardare le stelle –. Dice proprio: – Devo, – perché odia gli sprechi e pensa che non sia giusto sprecare tutta quella quantità di stelle che gli viene messa a disposizione.[6]
E non si fa troppa fatica a farlo; per dirla con l’I Ching:
Si attinge al pozzo senza impedimento.
Esso è fidato. Sublime salute!
Note
[1] Per riferimenti a questa caratteristica, cfr. l’articolo “Errare: il mestiere del fisico”, nel n. 6 de La Tigre di Carta.
[2] J.L.Borges, Argumentum ornithologicum, in Tutte le opere, vol. 1, Mondadori, Milano 1986, p. 1119.
[3] C. J. Conselice et al., “The Evolution of Galaxy Number Density At Z < 8 And Its Implications”, in The Astrophysical Journal, vol. 830, n. 2, 2016.
[4] Cfr. “Tornare sui propri passi”, nel n. 9 de La Tigre di Carta.
[5] La distanza di Betelgeuse è stata recentemente stimata tra i 600 e i 640 anni luce (cfr. Graham M. Harper et al., “A New VLA-Hipparcos Distance to Betelgeuse and its Implications”, in The Astronomical Journal, vol. 135, n. 4, 2008.
[6] Calvino, Palomar, in Romanzi e racconti, vol. 2, Mondadori, Milano 1992, p. 909.