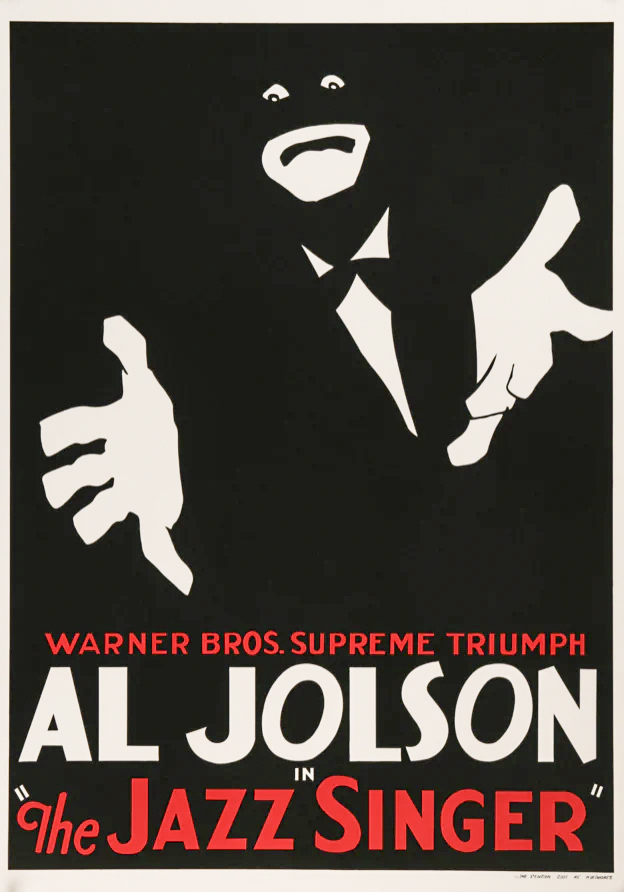di Federico Filippo Fagotto
///
Il venerabile patriarca cinese Línjì diceva: «Incontrando il Buddha sulla propria via, si uccida il Buddha!» – .
«Ma come?» – avranno risposto in coro i suoi allievi – «Tanta fatica per avvicinarsi al suo modello di perfezione e poi: track! Gli si dà il colpo di grazia? Bella riconoscenza».
Per capirci qualcosa, apriamo l’I King e leggiamo il testo dell’esagramma numero 21. Noi ci siamo arrivati in maniera più tortuosa, lanciando a turno quelle tre benedette monete. Era sera, c’erano due piccole candele sopra un basso tavolino, per stare attorno al quale noi quattro ci siamo seduti per terra, sopra dei comodi cuscini. Filippo, giunto in ritardo, si è dovuto “accontentare” del divano. Era arrivato in tempo, però, per assistere alle nostre perplessità sul risultato del lancio. L’esagramma si intitolava: Scï Ho – Il morso che spezza.. sembrava il nome di un film d’azione di dubbio gusto. L’immagine proveniva dal segno dell’esagramma, in cui le linee 1 e 6 sembrano le labbra di una bocca, i cui denti sono le linee spezzate (yin), in mezzo alle quali si intromette la linea 4: un ostacolo!
Per cavarsi d’impaccio, occorre serrare il morso fino a spezzare l’indesiderato ospite. Una bella noia, soprattutto mentre si mangia. Anche nell’esagramma di sviluppo (che completa la descrizione della scena) c’è qualcosa di simile. Dato, infatti, che le linee mobili (cambiando le quali si ottiene il secondo esagramma, che sviluppa il precedente) erano tutte tali tranne la prima in basso – cosa rara se pensiamo alle probabilità – si ricavò l’esagramma numero 5, dal titolo: L’attesa.
Qui si parla della pioggia, portatrice di vita e nutrimento, che tarda a cadere e lascia gli affamati alla loro capacità di resistenza. Insomma, sembrava che a tavola ci fossero problemi generali, forse la coincidenza con i cenoni natalizi non era casuale!
Nei rapporti col cibo, in effetti, gli orientali hanno sempre preferito maggior cautela. Si ricorda spesso l’incredulità del principe nel vedere il coltello usato dal macellaio con il filo della lama ancora intatto, nonostante anni di utilizzo. «Come sei giunto a tanta abilità?» – gli si chiese – «Colpisco nei grandi interstizi, guido il coltello nei grandi vuoti, secondo la conformazione naturale dell’animale», replicò. Bella risposta, un vero professionista, si dirà. Eppure è diffusa, fra le genti che preferiscono le bacchette alla forchetta, una tale perizia. Se ne accorse anche Roland Barthes, che la bacchetta di legno con cui mangiano gli orientali «non violenta mai l’alimento». Qual è, allora, il rapporto fra questa docile attesa e invece il fatto che talvolta, come recita l’I King, «bisogna mordere energicamente attraverso l’ostacolo» e che «gli ostacoli vengono eliminati con violenza»? Chissà. Per il momento, ci siamo arresi all’incertezza. Tra l’altro era il compleanno di una del gruppo, Martina, ed era già tardi per la cena.
Nei giorni successivi, ritrovata la lucidità, fu il momento di andare più a fondo. L’immagine di un morso che spezza, che viene paragonata dall’I King all’inflessibilità di un giudice nell’irrogare le pene e punire i renitenti, sembrava troppo forte, persino per l’austera morale confuciana. Ma a guardare meglio, si può trovare l’aiuto di un altro valore. Dei due trigrammi che compongono il segno, infatti, il primo – linee 1, 2, 3 (☳) – è il simbolo del tuono, dalla cui veemenza proviene il violento morso di cui s’è detto, mentre l’altro – linee 3, 4, 5 (☲) – è l’elemento del fuoco, anch’esso energico, ma più inconsistente, più «tenero». Insieme, tratteggiano la figura di un giudice di convinta inflessibilità ma mai esagerato nel decretare la sentenza. La sua virtù è, ancora una volta, come la pietanza di un cuoco che sa ben dosare due ingredienti. Ne nasce qualcosa di simile a una dialettica, termine che farebbe alzare il sopracciglio di un orientale, il quale però, pur inconsapevolmente, non manca di applicarla in ogni campo della pratica.
L’esempio migliore è quello che in Cina viene chiamato shou-li-po e dai cugini insulari shu-ha-ri. Si tratta di un metodo di esecuzione nato nella cerimonia del tè e nel teatro e poi applicato sottoforma di principio. È stato raffinato, in particolare, dai kata – ossia i modelli di movimento codificati delle arti marziali – ed è comune, pur con le debite varianti, a Judo, Karate e Aikido. Shu è l’atto di «conservare» e «proteggere» e consiste nell’acquisizione della tecnica del maestro per imitazione che, nella fase di apprendimento, va difesa nella sua forma canonica. Ha viene invece dal termine yaburu, sia nel senso di «lacerare» (破) che di «distruggere» (壊). È il momento trasgressivo, di rottura con la tradizione, senza il quale il valore del singolo non traspare, ed esso passa attraverso un vero atto di violenza. Gli esempi e i riferimenti, come sempre, si sprecano, anche perché nell’importanza del momento c’è la possibilità di fare a meno dell’autorità, di darsi al distacco e di richiamare quel vuoto di cui non si fregiava solo il cuoco col suo bel coltello, ma la cui conquista è il bizzarro vanto di tutti gli abitanti del Sol Levante. Ecco perché, verso l’illuminazione, nemmeno il Buddha in persona si deve intromettere. Se dovesse intralciare il cammino, si faccia come Edipo, in viaggio verso Tebe, fece con suo padre: senza pentirsene stavolta.
Il fatto che il terzo momento, ri, sia proprio questo, cioè la capacità di «trascendere» e separarsi per andare oltre, ricucendo in parte anche la rottura, ci permette di risolvere anche il secondo rovello: il rapporto con l’Attesa. Nel shu-ha-ri, infatti, i momenti che gravitano attorno alla distruzione dell’ostacolo sono due, perché due sono le diverse forme dell’attendere, una che precede, l’altra successiva. La prima è la gestazione che porta alla rottura. Un buon giudice, ad esempio, non è precipitoso ma prende decisioni, anche esiziali, sempre a ragion veduta. Saper distruggere, nel senso di poter rinunciare, è l’arte più difficile. Come trattenersi, ormai, dal ricordare la convinzione di Malraux sulla differenza fra l’uomo sensibile e il vero artista. Quest’ultimo, infatti, è colui che «solo fra quanti sono affascinati dalle opere d’arte, vuole anche distruggerle».
Per non allontanarci troppo però, occorre tornare in Asia, ma la strada passa traverso l’India. Qui scopriamo che l’intera questione era sulla scrivania già da qualche millennio. Śiva, il «favorevole», il «fausto», colui che ha il compito di tutelare e conservare il creato, è anche hara, colui che «distrugge», il che non significa che fosse molto indeciso, ma che l’atto distruttivo serve al rinnovo dei cicli cosmici e alla rimozione dell’ostacolo che separa il Sé individuale da quello universale. Ma nella logica della reiterazione del tempo, anche il momento successivo, di trascendenza, non è forse, a sua volta, una nuova forma di attesa, quasi un tentativo di conservazione post hoc?
Ecco come mai l’esagramma l’Attesa è quello di sviluppo. Il talento del giudice, ad esempio, è anche evitare l’accanimento. Una volta eletto il cenno castigatore, la mano va fermata. Una volta che il morso spezza, si ricomincia a mangiare. Il fuoco, allora, è l’elemento che illumina la situazione, porta chiarezza, rassicurando il giudizio, ed essa si diffonde ovunque, prima e dopo il momento decisivo. Questo suggerisce forse l’I King. Con la luce del fuoco, si guadagna così un tesoro che brilla. «Bisogna raccogliersi onde essere come l’oro giallo» – dice infatti il commento all’esagramma 21 – «ovverosia imparziali e schietti come l’oro».
Chiudiamo allora il libro, stacchiamoci anche da lui, e cerchiamo un’immagine dei kinstugi, tanto per ricordarci, ancora una volta, che il cibo la fa da padrone. Cosa sono? Si tratta di ceramiche per il tè o per il pasto che si sono incrinate o rotte. Noialtri le butteremmo via senza pensarci due volte. In Giappone no. Si usa una leggera colata di oro oppure di polvere dorata per rimarginare la crepa. Anziché il risultato di uno scadente bricolage, viene considerata arte purissima. Anche qui, la luce dell’oro conserva e permette al vaso di proseguire nell’attesa del tempo, pur intervenendo dopo la rottura. Bisogna sapere però che, prima o poi, la ciclicità e la ripetizione della dinamica ci chiederanno di essere capaci di distruggere ancora e superare i nostri attaccamenti.
Abbagliato dai lucori dell’oro che sfogano dal Kinkaku-ji – il Padiglione rivestito d’oro che i visitatori ammirano nei pressi di Kyōto – anche il protagonista dell’omonimo romanzo di Mishima coglie, in un attimo, una verità sull’atto della distruzione: «Sono suscettibili di distruzione solo cose indistruttibili come il Padiglione d’oro», afferma. Non gli mancò altro per prendere la sua dissennata decisione:
Questo modello di bellezza – pensai – fra non molto finirà in cenere
Per le calligrafie ringraziamo il maestro Bruno Riva e il sostegno dell’associazione shodo.it