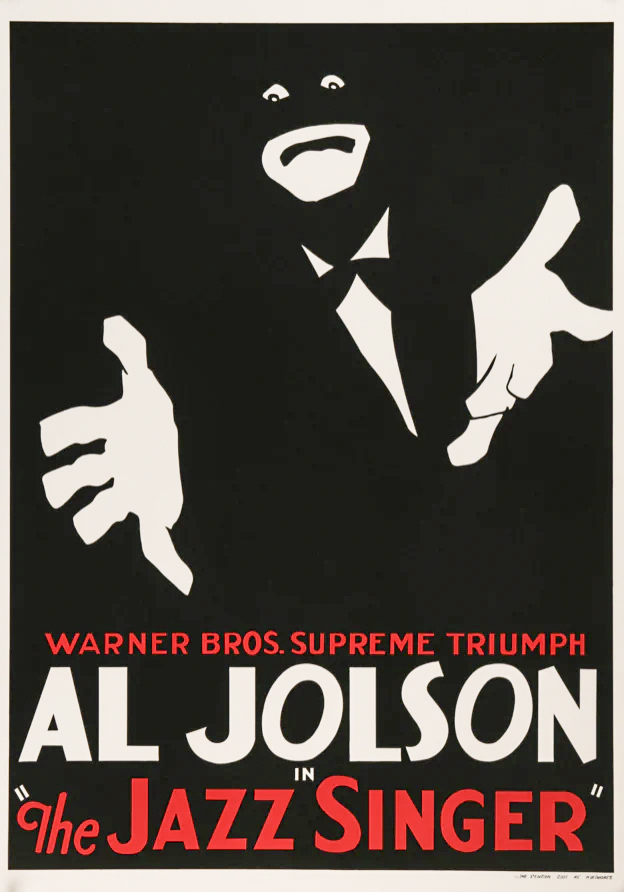di Martina De Martino
///
Il cinema di guerra e la figura del soldato: nel gioco fra il tutto e le parti, il conflitto diventa vero protagonista, ma il singolo può ancora suscitare empatia. Con questo espediente simbolico, Chaplin cerca di salvare l’amore per l’umanità.
Non sembra un’esagerazione sostenere che l’estrema popolarità del mezzo cinematografico e la sua così ampia e rapida diffusione abbiano certamente contribuito a definire la nostra risposta immaginativa a concetti come il futuro, il mistero, il sovrannaturale, e, perché no, anche la guerra e con essa l’esercito. In particolar modo, la potenza egemonica del cinema hollywoodiano ha ottenuto effetti dirompenti sull’immaginario collettivo occidentale e non solo, facendo sì che stereotipi nati sul set si sostituissero spesso a immagini reali. Possiamo dunque chiederci: qual è la prima immagine che ci viene in mente quando pensiamo all’esercito? Nel mio caso, si tratta delle braccia alzate al cielo dal personaggio interpretato da Willem Defoe, colpito a morte in battaglia in Platoon (Oliver Stone, 1986); altri potrebbero citare le reclute atterrite davanti alle urla del sergente istruttore in Full Metal Jacket (Stanley Kubrick, 1987), lo sbarco in Normandia ricostruito da Steven Spielberg in Salvate il soldato Ryan (1998), o l’esercito dei cloni ideato da George Lucas nella saga di Star Wars (1977). Gli esempi che potremmo citare sono innumerevoli, attraversano la storia del cinema e gran parte dei suoi generi; in questo breve spazio vorrei però riflettere su alcune caratteristiche che sembrano costanti proprio all’interno di questa grande varietà di produzioni. Quella che segue è una considerazione, spero mi venga concesso, solo apparentemente banale: i film di guerra tendono a svolgere la propria trama intorno al vissuto di un solo uomo o di un gruppo ristretto di individui. Certo, questa è una caratteristica essenziale di gran parte delle narrazioni cinematografiche, se non addirittura delle narrazioni in generale; cosa c’è quindi di particolarmente significativo in questi casi? La questione diventa interessante se consideriamo come gli autori di questi film abbiano solitamente come obiettivo quello di rappresentare l’esperienza, così totale e totalizzante, della guerra, nelle sue più ampie e varie sfaccettature. La sensazione che lascia gran parte di queste pellicole, infatti, sembra proprio volerci condurre a guardare alla guerra stessa come la vera protagonista e non come una semplice ambientazione o uno sfondo occasionale per il racconto della storia di un individuo. Potremmo quindi affermare che i film di guerra, più che tutti gli altri generi, giochino sull’inversione sineddotica dei ruoli tra la parte, ovvero il singolo soldato di cui vengono narrate le pur straordinarie vicende, e il tutto, ossia il conflitto in sé e le sue dinamiche più oscure. C’è però forse una seconda ragione che supporta l’espediente, se così lo possiamo chiamare, di una narrazione concentrata sul ‘singolo’, volta però a dipingere un affresco più ampio sul ‘tutto’. Raccontare le vicissitudini personali vissute da un personaggio aiuta a raggiungere in maniera più immediata la sensibilità dello spettatore che guarda il film e a stimolare in esso una più diretta reazione emotiva di empatica compartecipazione. Il protagonista, l’eroe, non è che un uomo fra i tanti, un soldato in un esercito, e la sua storia non è che una storia. Non è nulla di più che un singolo in una moltitudine, come noi tutti i giorni, perfino quando siamo seduti tra le file delle poltrone di un cinema. Perché in fondo è proprio questo il tentativo dei film di guerra: raccontare come l’individuo possa trovare un ruolo in una collettività; ricordare a chi guarda che il passato, il presente e il futuro si costruiscono su destini comuni, e che la storia insegna che ogni uomo non è che un pedone in gioco più grande. La scelta così comune di ruotare la narrazione intorno al punto di vista di un singolo soldato, riflette anche una sorta di uniformità strutturale che possiamo riconoscere in questo genere di pellicole. Sembrerà un azzardo, ma, a voler ben guardare, i film di guerra, che siano ambientati in un futuro fantascientifico, o cerchino una ricostruzione quanto più fedele di un reale evento storico, si somigliano un po’ tutti. Sì, forse si stratta di una semplificazione e certamente si potrebbe obiettare che, al contrario, questo sia stato il genere che col tempo è divenuto oggetto delle più disparate elaborazioni. Tutto vero. Ma allora come mai quando guardiamo un film del genere abbiamo quasi sempre un’idea piuttosto precisa di come si svilupperà la trama? Cosa ci aspettiamo da un film di questo tipo? Ci aspettiamo di trovare come protagonista un soldato semplice, il più delle volte caratterizzato come un uomo comune, senza particolari doti o talento, che nello svilupparsi della narrazione si trova inconsapevolmente ad occupare il ruolo dell’eroe e che, riscoprendo in sé stesso abilità e forza d’animo nascoste, porterà ad una risoluzione positiva del conflitto, al raggiungimento di un obiettivo insperato, se non addirittura alla vittoria di una guerra. Pensiamo soltanto ad alcuni dei film usciti di recente. In Monuments Men di George Clooney (2014), un gruppo di improbabili soldati riesce nella rischiosa missione di salvare opere d’arte dalla mano nazista; in Edge of Tomorrow di Doug Liman (2014), un soldato inesperto e timoroso diviene l’unica speranza per salvare la Terra da un’invasione aliena; in Guardiani della Galassia di James Gunn (2014) una squadra di reietti e criminali salva la situazione unendo le forze contro un nemico comune. Questi sono solo alcuni degli esempi che potremmo citare, ma essi testimoniano come, pur conservando sostanziali differenze, il percorso narrativo sia generalmente molto simile. Con anni di pratica e un po’ di intuito, possiamo addirittura individuare il momento preciso in cui il protagonista subisce la trasformazione da soldato comune, trasportato dalla moltitudine nel quale è inserito, a eroe coraggioso, comandante inaspettato e guida indomita. Spesso questo passaggio è accompagnato da un’esplicita proclamazione di intenti: chi non si aspetta prima di una grande battaglia il discorso ricco di pathos del capitano, dell’eroe che invita i suoi soldati, ancora timorosi e inesperti, a mostrare il coraggio che, certamente, nascondono nel loro animo di uomini semplici? Quante volte abbiamo assistito a potenti chiamate alle armi – «Ma non è questo il giorno!» – a inni alla libertà – «Possono toglierci la vita, ma non ci toglieranno mai la libertà!» – a dichiarazioni di fratellanza e rinnovate unità familiari, e così via? Potremmo allora chiederci come mai, nonostante la prevedibilità del racconto, i film di guerra abbiano ancora così tanto fascino sugli spettatori. La risposta che mi sono data è questa: perché i film di guerra sono film sull’esercito, e i film sull’esercito sono film sugli uomini. Il messaggio che questi film cercano di mandare mi sembra sia sempre lo stesso: il singolo è più forte nella moltitudine: «La solidarietà è cosa allegra», come direbbe l’I King, perché l’unione è l’unica soluzione. Nulla di più. C’è un film che forse più di tutti ha cercato di trasmettere questo messaggio, e, caso vuole, anch’esso rispetta quelli che abbiamo descritto come canoni tipici del film di guerra. Mi riferisco al capolavoro di Charlie Chaplin Il Grande Dittatore del 1940. Il film percorre due linee narrative intrecciate ma distinte: da un lato troviamo un semplice barbiere ebreo, soldato inetto nella prima guerra mondiale che perde la memoria in azione e si risveglia in un mondo di discriminazione e odio razziale che non riconosce; dall’altro si contrappone il grande dittatore di Tomania, chiara parodia del leader nazista Adolf Hitler, con irrefrenabili manie di conquista, brama smisurata per il potere e un esercito in tasca. Chaplin, con questo film, fornisce allo spettatore uno spunto di riflessione che però compie un passo in più rispetto ai film di guerra che abbiamo analizzato prima. Ci racconta, infatti, la moltitudine, la schiera e la divisa come armi a doppio taglio. Il messaggio che vuole comunicare non si limita ad un richiamo alla solidarietà fra gli uomini: il suo eroe è prima membro involontario di un esercito dove non ha mestiere, per poi ritrovarsi parte di una comunità isolata e maltrattata. Attraverso questo personaggio, Chaplin racconta il crollo delle certezze e della stabilità emotiva, il senso di inevitabilità e di impotenza, l’annichilimento di ogni velleità individuale che l’isolamento e l’estraneazione comportano. Negli ultimi atti del film, il barbiere per salvare la propria vita si trova costretto ad assumere i panni del dittatore: questo scambio di persona non solo gli garantisce la libertà che altrimenti gli era negata, ma gli conferisce anche il potere smisurato di decidere delle vite altrui. Ed è proprio nel momento in cui all’uomo semplice viene chiesto di parlare alle masse e di prendere la guida del popolo che il grido di speranza si fa più forte. Guardando lo spettatore diritto negli occhi, Chaplin si fa portavoce di uno dei più forti richiami all’umanità che si ricordi. L’uomo può scegliere di rifugiarsi in un esercito, può rimettere la sua autonomia e condividere la sua forza, ma l’efficacia di questo estremo atto di solidarietà può aver successo solo se chi si erge a capo e guida di questa nuova comunità non dimentica la sua umanità.
Soldati! Non consegnatevi a questi bruti, che vi disprezzano, che vi riducono in schiavitù, che irreggimentano la vostra vita, vi dicono quello che dovete fare, quello che dovete pensare e sentire! Che vi istruiscono, vi tengono a dieta, vi trattano come bestie e si servono di voi come carne da cannone. Non datevi a questi uomini inumani: uomini-macchine con una macchina al posto del cervello e una macchina al posto del cuore! Voi non siete delle macchine! Siete degli uomini! Con in cuore l’amore per l’umanità! Non odiate! Solo chi non è amato odia! Chi non è amato e chi non ha rinnegato la sua condizione umana!1
Note:
1. You Tube: Charlie Chaplin, The Great Dictator, “Final speech”