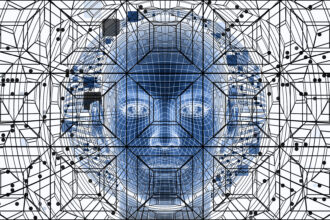“Post-verità”: è la parola dell’anno. Dare un nome a un fenomeno forse ci dà l’illusione di dominarlo, ma a ben vedere non lo spiega affatto. Se abbiamo smesso di credere ai fatti, a che cosa crediamo invece?
In un articolo comparso sul settimanale francese L’Obs, Pierre Haski sostiene che siamo entrati in una nuova èra, in cui nessuno crede più ai fatti[1]. Il nome proposto per questa nuova epoca è presto trovato grazie a un libro di Ralph Keyes: The Post-Truth Era, lʼera della “post-verità”. Il riferimento polemico è evidentemente al crescente successo dei movimenti politici di stampo populista, che guadagnano consensi tramite una narrazione della realtà semplicistica e spesso condita di molte falsità, ma noi potremmo aggiungere anche la crescente sfiducia della popolazione verso le autorità scientifiche e il proliferare di pratiche e discipline “alternative” (come ben sa chi legge la rubrica di medicina della nostra Yasanthi).
Oggi, chiunque affermi di essere “esterno” allʼestablishment, politico o scientifico che sia, riscuote immediatamente il sostegno di moltissime persone. Seppur in misura meno appariscente, questo fenomeno investe anche la sfera religiosa, con la crescente diffusione di sedicenti culti orientali o degli aderenti ai Testimoni di Geova. Tali fenomeni suggeriscono una grande avversione per tutte quelle narrazioni del mondo che sembrano provenire dallʼalto, dai potenti o comunque da istituzioni dotate di autorità. La corruzione che storicamente si è sempre verificata in questi ambiti non è più vista come una deviazione particolare, ma come endemica e costitutiva del potere stesso. Tuttavia, venendo a mancare un riferimento comune, si crea un bisogno di verità nuove, di interpretazioni alternative che riempiano il vuoto lasciato dalle grandi narrazioni collettive da cui ci sentiamo traditi. La nostra epoca allora non ha smesso di cercare la verità, anzi, ne sente più che mai la mancanza. Solo che ha perso i punti di riferimento per trovarla.
Ma è possibile recuperare dei criteri comuni sulla ricerca della verità senza che questi siano imposti, per così dire, da un potere costituito? Qui la filosofia può darci un piccolo aiuto. Per procedere con ordine, cominciamo col chiederci cosa intendiamo con “verità”, e cioè che aspetto hanno quelle proposizioni del linguaggio che chiamiamo “vere”. Non mi è possibile tracciare qui una mappa di tutte le teorie filosofiche sul concetto di verità, nemmeno di quelle più significative. Mi servirò quindi della complicità dellʼI Ching, che stavolta ci propone il tema La compagnia fra gli uomini, per esporre solo una di queste teorie, quella che io ritengo più convincente. Lʼimmagine dellʼesagramma 13 recita così:
Il cielo insieme al fuoco:
L’immagine della compagnia fra uomini.
Così il nobile ripartisce le stirpi e distingue le cose.
Ciò sembra suggerire il fatto che il linguaggio, grazie al quale classifichiamo e denominiamo gli oggetti della nostra esperienza, sia un prodotto collettivo. Banalmente, il linguaggio noi lo apprendiamo: appena nati, i bambini non conoscono le parole, non danno nomi alle cose e non comprendono chi parla loro. Il processo di apprendimento avviene per astrazione, attraverso prove e correzioni. Per esempio, può accadere che il maestro (molto spesso un genitore) attiri lʼattenzione del pupo su un cane e dica ad alta voce “cane”. Il discente non ha ancora modo di sapere se quella parola sia il nome per quel singolo oggetto, per una delle sue parti o per un più ampio gruppo di oggetti di cui esso sarebbe una parte[2]. Se successivamente il maestro indicasse un altro cane e pronunciasse di nuovo “cane”, il discente potrà allora comprendere che lʼuso di quella parola non è limitato al cane di casa (il quale, presumibilmente, viene chiamato spesso anche con un nome diverso), bensì è riferito a qualcosa che ha caratteristiche associabili a entrambi gli esseri. La parola “cane” potrà allora indicare tutti gli animali a quattro zampe, oppure tutti quelli con il pelo. Ma nel momento in cui il bambino provasse a usare la parola “cane” in presenza per esempio di un gatto, il maestro lo correggerà, riducendo così ulteriormente lʼinsieme delle associazioni consentite da quella parola, e così via, circoscrivendone sempre di più la portata. Tuttavia, come ha spiegato Michele nello scorso numero, non è mai possibile escludere a priori lʼeventualità di futuri equivoci[3]. Avviene così che lʼunico criterio per sapere se stiamo usando il linguaggio correttamente è osservare se gli altri ci capiscono, cioè se si comportano come ci aspetteremmo in seguito alla nostra comunicazione.
Lo stesso accade anche quando, oltre a nominare oggetti, proviamo ad attribuire loro dei predicati che possono essere veri oppure falsi. In questo caso sembra però più difficile credere che si tratti di un patto collettivo: in fondo, se io affermo che “fuori piove”, mi basta guardare fuori dalla finestra per sapere se è vero. La verità ha questa essenziale caratteristica di manifestarsi come indipendente dalla nostra volontà, dal nostro accordo e perfino dalla nostra esistenza. Resta il fatto, comunque, che noi vi abbiamo accesso solo attraverso la nostra esperienza e mediante il linguaggio (non abbiamo mai verità “in sé”, ma solo proposizioni vere), e il linguaggio è un fatto sociale.
Vero e falso è ciò che gli uomini dicono; e nel linguaggio gli uomini concordano[4].
Affinché noi accettiamo una proposizione come vera, essa deve apparirci prima di tutto coerente con tutte le nostre altre credenze fondamentali (quelle, per intenderci, che non abbiamo nemmeno bisogno di esprimere tanto sono per noi ovvie). Per credere a qualcuno che affermi di aver visto un fantasma, dovremmo mettere in discussione tutte le credenze che abbiamo sul mondo, mentre per credere che sia folle basta metterne in dubbio soltanto una. La stessa cosa varrebbe forse se fossi io a vedere il fantasma: lʼevidenza sensibile talvolta può non bastare a convincerci se è troppo incoerente con ciò sappiamo del mondo, e fra le cose che sappiamo vi è che le allucinazioni possono capitare. Questa rete di credenze si rinforza e si modifica nel nostro interagire in comunità. Pensate a quanto sia cambiata nella storia la nostra concezione del mondo, e a quanto cambi da cultura a cultura.
Ora, potremmo pensare che tale idea di verità conduca necessariamente al relativismo: a seconda di quando e dove viviamo potremmo percepire la verità in modo totalmente diverso. Di conseguenza non ci sarebbe alcun criterio comune per ricercarla, e ci si potrebbe sentire frustrati, come Nietzsche in Verità e menzogna[5], dal fatto che le verità siano «illusioni di cui si è dimenticato il carattere illusorio», oppure si può osservare che questo fa della verità un fatto dominabile dallʼuomo. Ma il soggettivismo non è lʼesito a cui si è condannati: sebbene non sia più possibile sostenere lʼidea di verità assolute, questo non significa che non esistano criteri intersoggettivi validi per tutta la comunità degli uomini come oggettivi. Quando con il nostro linguaggio sviluppiamo descrizioni del mondo che si rivelano adeguate a manipolare in modo efficace la nostra esperienza e a consentirci di programmare con successo le nostre azioni, allora esse diventano per noi, in quel momento, credenze vere. Il fatto che esistano tante comunità più o meno isolate può forse far sì che gli uomini sviluppino sistemi di credenze un poʼ diversi tra loro, ma tutti questi sistemi, senza eccezione, presuppongono una qualche forma di coerenza. Senza di essa, infatti, non sarebbe possibile interpretare efficacemente il mondo. Tali sistemi di credenze sarebbero quindi confrontabili in base alla loro capacità di offrire una descrizione del mondo il più possibile comprensiva e priva di contraddizioni. Lʼefficacia di unʼinterpretazione fa quindi così tuttʼuno con la sua verità.
Quello che accade oggi è che, grazie ai social network, ma anche a molti notiziari che hanno paura di contraddirci, qualunque teoria, per quanto sgangherata, può raggiungere un grande bacino di persone che già la appoggiano, rinforzandola. La teoria così evita quel naturale processo di correzione che avviene quando essa incontra la resistenza delle comuni credenze che potrebbero metterla alla prova, selezionando i propri interlocutori solo fra coloro che la supportano. Teorie siffatte, prive di una effettiva messa alla prova, sono deboli e pericolose. Viceversa, le teorie pubbliche delle autorità, per quanto nulla vieti che si rivelino false, sono comunque più attendibili per il solo fatto di essere il risultato del confronto con una platea molto più vasta ed eterogenea. Di quante più obiezioni una teoria tiene conto, tanto più essa diventa solida. Rifiutare il dibattito con le posizioni ufficiali, rivendicando unʼefficacia su un piano alternativo, esterno a esse, significa rinunciare a disporsi su quellʼunico piano in cui diversi sistemi possono essere confrontati[6] e che, in ultima analisi, è anche il solo modo in cui la compagnia fra gli uomini può misurare la loro verità.
Note
[1] Qui potete leggere lʼarticolo in italiano: P. Haski, “Benvenuti nell’era che non crede più ai fatti”, in Internazionale, 14 settembre 2016.
[2] Lo stesso concetto di “oggetto”, trattandosi di unʼaltra parola, deve essere appreso.
[3] In altre parole, la regola dʼuso di una parola è sottodeterminata rispetto a tutte le sue possibili applicazioni.
[4] L. Wittgenstein, Ricerche filosofiche, tr. it. di R. Piovesan e M. Trinchero, Einaudi, Torino 2014, § 241.
[5] F. Nietzsche, Su verità e menzogna in senso extramorale, Editori Riuniti, Roma 2011, p. 13.
[6] Non a caso, la medicina “alternativa” che funziona smette di essere alternativa.